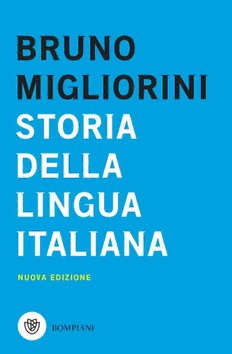
Storia della lingua italiana PDF
Preview Storia della lingua italiana
TASCABILI BOMPIANI 31 Migliorini_post-ciano.indb 1 11/04/19 16:19 BRUNO MIGLIORINI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Introduzione di Ghino Ghinassi Postfazione di Massimo Fanfani I GRANDI TASCABILI BOMPIANI Migliorini_post-ciano.indb 3 11/04/19 16:19 Progetto grafico: Polystudio Copertina: Zungdesign ISBN 978-88-587-8296-5 www.giunti.it www.bompiani.it © 2019 Giunti Editore S.p.A./Bompiani Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia Piazza Virgilio 4 – 20123 Milano – Italia Prima edizione digitale: maggio 2019 Migliorini_post-ciano.indb 4 11/04/19 16:19 INTRODUZIONE Migliorini_post-ciano.indb 5 11/04/19 16:19 Migliorini_post-ciano.indb 6 11/04/19 16:19 BRUNO MIGLIORINI E LA SUA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA a Bruno Migliorini, maestro e uomo Quando, cinquant’anni fa, al momento di insediarsi nella cattedra di Storia della lingua italiana alla Facoltà di Lettere di Firenze (la prima, istituita, si può dire, ad personam, per valorizza- re a pieno le sue originali ricerche, e per permettergli di ritornare in patria dall’“esilio” svizzero), dette inizio ai corsi della nuova disciplina accademica, Bruno Migliorini, da quell’uomo retto e corretto che era, oltre che strenuamente impegnato nei suoi studi, s’impose subito il dovere di giustificare questo provvedimento eccezionale, dando l’avvio ai lavori preparatori per un’opera che mancava ancora all’Italia: una storia della lingua italiana. Lo attesta Migliorini stesso nelle prime righe della “Premessa” del libro che viene ora ristampato, dopo quasi un trentennio dalla prima edizione (che uscì nel 1960).1 Che una storia della lingua mancasse veramente all’Italia potrebbe essere messo in dubbio da chi si ricordasse che fin dal 1 Per le vicende che portarono Migliorini alla cattedra fiorentina si veda in particolare F. Mazzoni, Bruno Migliorini. Commemorazione tenuta a cura della Società Dantesca Casentinese pro cultura e pubblicata negli Atti della “Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze” di Arezzo, Arezzo 1981, spec. pp. 11 e sgg.: l’insegnamento miglioriniano a Firenze cominciò il 5.11.1938. L’anno dopo la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma chiamava Alfredo Schiaffini a ricoprire una cattedra analoga: cfr. A. Schiaffini, Italiano mo- derno e antico, a cura di T. De Mauro e P. Mazzantini, Milano-Napoli 1975, p. 343; e per diversi anni queste due rimasero le sole cattedre di Storia della lingua italiana esistenti nelle università italiane. I modi e i motivi che porta- rono in quel periodo all’attivazione di una tale disciplina universitaria meri- terebbero un’indagine specifica: chi scrive ricorda che Migliorini attribuiva una parte importante in questa vicenda al vivo interessamento dell’allora ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai. Migliorini_post-ciano.indb 7 11/04/19 16:19 viii INTRODUZIONE Settecento (per omettere episodi precedenti, frammentari e occa- sionali) personaggi illustri avevano affrontato un tema simile, o almeno avevano apposto un’etichetta simile ad alcune loro opere. Ma si trattava di opere diverse e nate in un clima lontano: o volte a ribadire, di fronte a un pubblico straniero, le glorie passate della lingua e letteratura italiana (non senza qualche preoccupazione per la sua sorte futura), come la History of the Italian Tongue (1757) di Giuseppe Baretti; oppure a integrare, sulle tracce del Muratori, l’elemento “lingua” nelle origini medievali della civiltà italiana, preparando così, di lontano, materiali e argomentazioni per quella che sarà la tesi del suo “primato” in Europa: tale appare, per esempio, il capitolo “Lingua” nel Risorgimento d’Italia (parte II, capo I) di Saverio Bettinelli (1775). Gli incunaboli settecenteschi della storia della lingua italiana trovano insomma il loro baricen- tro in motivazioni assai distanti dal nostro tempo: in particolare nel desiderio di una piena legittimazione del nostro idioma di fronte al temibile dilagare del francese, che pareva ormai travol- gere ogni difesa frapposta dalla nostra lingua, la “langue douce, sonore, harmonieuse” (Rousseau) di Petrarca, Ariosto e Tasso. Naturalmente in quest’epoca dire “lingua” significava ancora, in larga parte, dire “letteratura”; e per chi risiedeva e studiava o insegnava all’estero “letteratura italiana” significava inevitabil- mente “letteratura in lingua italiana”. È così che una settantina d’anni dopo la History del Baretti, il Foscolo compilò, ancora per un pubblico inglese, le sue lezioni, notevolmente più ampie, sulle Epoche della lingua italiana (1823-25). L’animo nel frattempo era mutato: dalla difesa di fronte al francese si era passati alla sicura affermazione della lingua come contrassegno ineludibile di identità nazionale: “Ogni nazione ha una lingua,” affermava il Foscolo in una lezione pavese del 1809, “Ogni letterato deve parlare alla sua nazione con la lingua patria.”2 E a lungo si sognò, nel rifiorimento romantico della medievistica, di una storia che, 2 Cfr. U. Foscolo, Lezioni, articoli di critica e di polemica (1809-1811), ed. critica a cura di E. Santini (vol. VII dell’Edizione nazionale delle Opere), Firenze 1933, p. 65. Migliorini_post-ciano.indb 8 11/04/19 16:19 INTRODUZIONE ix seguendo a ritroso il sentiero della lingua comune, superando le angustie regionali e municipali, attingesse le origini della nazione e della civiltà nazionale: si accinsero a questo compito, negli anni attorno al 1830, prima Giuseppe Grassi, e poi, dietro il suo esempio, Cesare Balbo, senza peraltro giungere, né l’uno né l’altro, a compiere i loro lavori.3 Frattanto arrivavano in Italia i primi echi dei nuovi indirizzi presi dalla linguistica storica in ambiente germanico, e sul loro stimolo prendeva l’avvio, particolarmente a Milano, per opera precipua di Bernardino Biondelli e di Carlo Cattaneo, in quel vivacissimo laboratorio scientifico che fu la rivista Il Politecnico, diretta dal Cattaneo stesso, quell’indagine rigorosa sull’origine e gli sviluppi degli idiomi dialettali italiani e sul loro complesso rapporto con la lingua comune, che portò alla formazione di studiosi quali Graziadio Isaia Ascoli e al costituirsi di una scuola italiana di glottologia.4 3 In generale sulla viva e rinnovata aspirazione a una “Storia d’Italia” nella prima metà dell’Ottocento cfr. B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, Bari 19302, cap. V. Della incompiuta storia della lingua italiana del Grassi solo ora si è ritrovato il manoscritto: cfr. C. Marazzini, “La linguistica di Manzoni”, in Liceo linguistico Cadorna – Facoltà di Lettere – Cattedra di Letteratura italiana A dell’Università di Torino, Manzoni e l’idea di letteratura, Torino 1987, pp. 59-66, a p. 63; su essa cfr. C. Balbo, Pensieri ed esempi con l’aggiunta dei Dialoghi di un maestro di scuola, Firenze 1854, pp. 226 e sgg., che al ricordo del Grassi e della sua opera fa seguire un suo interrotto abbozzo di storia della lingua italiana (rifluito poi e ampliato in alcune sezioni del Sommario della Storia d’Italia del 1846). Si ricordino an- che le parti dedicate alla lingua in opere quali la Storia della Toscana di L. Pignotti (1813-14), in bilico tra storia regionale e storia nazionale. Riflessioni più aperte e penetranti proponeva qualche anno dopo G. Capponi nelle Lezioni sulla lingua italiana (1827-35: la quarta e ultima è peraltro perduta), che preparavano da lontano gli excursus linguistici della sua tarda Storia della Repubblica di Firenze (1875). 4 Su ciò si veda compendiosamente Bernardino Biondelli e la linguistica preascoliana di D. Santamaria (Roma 1981), di cui è stato pubblicato finora soltanto il primo volume. Contributi fondamentali sull’argomento si trovano peraltro in S. Timpanaro, Classicismo e Illuminismo nell’Ottocento italiano, Pisa 1969, spec. nella sezione su “Carlo Cattaneo e Graziadio Ascoli” (pp. 229 e sgg). Migliorini_post-ciano.indb 9 11/04/19 16:19 x INTRODUZIONE Suggestioni letterarie, polemica antifrancese, aspirazioni na- zionali, nuovi metodi glottologici: tutto un complesso di fermenti culturali, che accompagna le vicende risorgimentali nel fervido clima sette-ottocentesco, e che sembrò più volte sul punto di dare all’Italia, accanto a una storia politica e civile e a una sto- ria letteraria, anche una storia della lingua. Ma non si riuscì che a produrre, per allora, se non frammenti, abbozzi, ricerche d’occasione o di dettaglio. Del resto il panorama italiano non si diversificava molto, per questo aspetto, da quello europeo: la storia della lingua non trovava ancora una sua sicura ubicazione, divisa com’era tra le descrizioni della storia letteraria e i nuovi schemi metodici della linguistica storica.5 Negli ultimi decenni del secolo, fondata l’Italia e fattosi più pacato il clima dell’indagine storica, ci si rendeva ben conto che una storia della lingua italiana restava ancora nel limbo delle aspirazioni. “Chi pensi gl’importanti lavori fatti da parecchie nazioni sulle lingue e i dialetti,” scriveva il De Sanctis nel 1869, recensendo le prime Lezioni di letteratura italiana del Settembrini, “maraviglierà come in Italia, dove questi studi ebbero origine, stiamo ancora disputando se la lingua dee prendersi da’ vivi o da’ morti, e quale sia una forma di scrivere italiana, e niente ancora abbiamo che rassomigli ad una storia della nostra lingua e de’ dialetti, dove siano rappresentate le varie forme, che la lingua e il periodo ha prese nelle diverse epoche.”6 Le aspirazioni peraltro non venivano meno; ma non veniva meno neanche la coscienza delle grandi difficoltà da superare. Scriveva il romanista Pio Rajna, 5 Per questa posizione ancora incerta della storia della lingua nel corso dell’Ottocento si vedano i primi paragrafi del saggio di A. Varvaro, “Storia della lingua: passato e prospettive di una categoria controversa” (ora nel libro dello stesso Varvaro, La parola nel tempo. Lingua, società e storia, Bologna 1984, pp. 9-77): al saggio del Varvaro, uscito la prima volta in Romance Philology nel 1972-73 e fondamentale per il nostro tema, avrò occasione di rinviare ancora nel corso di queste pagine. 6 Verso il realismo. Prolusioni e lezioni zurighesi sulla poesia cavalleresca, frammenti di estetica, saggi di metodo critico, a cura di N. Borsellino, Torino 1965, pp. 316-317. Migliorini_post-ciano.indb 10 11/04/19 16:19
