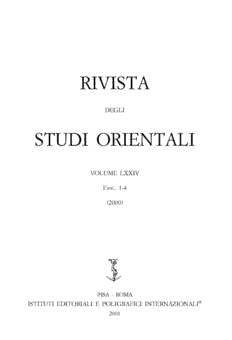
Rivista degli studi orientali. Annate 2000-2007 PDF
Preview Rivista degli studi orientali. Annate 2000-2007
RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI VOLUME LXXIV FASC. 1-4 (2000) PISA ⋅ ROMA ISTITUTI EDITORIALI E POLIGRAFICI INTERNAZIONALI 2001 RIVISTA DEGLI STUDI ORIENTALI Trimestrale Prezzo d’abbonamento per l’anno 2000 Italia Lire 200.000 ( 103,30) ⋅ Estero US$ 250 (comprensivo dell’intera annata della rivista e dei due supplementi) I versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale n. 13137567 o tramite carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, American Express, Carta Si) ISTITUTI EDITORIALI E POLIGRAFICI INTERNAZIONALI PISA ⋅ ROMA Casella postale n. 1 ⋅ Succursale 8 ⋅ I 56123 Pisa Uffici di Pisa: Via Giosuè Carducci 60 ⋅ I 56010 Ghezzano La Fontina (Pisa) Tel. +39 050878066 (r.a.) ⋅ Fax +39 050878732 E-mail: [email protected] Uffici di Roma: Via Ruggero Bonghi 11⁄b (Colle Oppio) ⋅ I 00184 Roma Tel. +39 0670452494 (r.a.) ⋅ +39 0670476605 E-mail: [email protected] La Casaeditrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilitàdi richiederne la rettifica o la cancellazione previa comunicazione alla medesima. Leinformazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati nuove proposte (L. 675⁄96). Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo eseguiti, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta degli Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa ⋅ Roma http:⁄⁄www.iepi.it Copyright 2001 by Università degli Studi di Roma ‘‘La Sapienza’’ ISSN 0392-4866 ERRATA CORRIGE Nell’indice posto all’inizio del volume e in terza pagina di copertina, l’indicazione numerica delle pagine è sbagliata e va sostituita con quella qui sotto stampata. INDICE DEL VOLUME SETTANTAQUATTRESIMO 1-4 ARTICOLI......................................................................................................................................... Pagina A. ROCCATI, Ricerche sulla scrittura Egizia – V........................................................................... 1 M. GARGIULLO, L’uso di modelli ellenistici in Proverbi I-IX...................................................... 9 M. KOSSMANN, Les désinences modales en berbère...................................................................... 25 E. GALDIERI, Sull’architettura islamica in Sicilia............................................................................ 41 L.E. PARODI, A Creative Dialogue.................................................................................................. 75 P. CORRADINI, The Worship to the Sovereigns of the Past......................................................... 93 G. RICCIARDOLO, Gli scritti pro e contro i missionari gesuiti..................................................... 141 M.G. VIENNA, Modelli letterari della modernizzazione giapponese............................................ 159 NECROLOGIO F. SQUARCINI, Ricordando l’opera di Wilhelm Halbfass............................................................... 199 RECENSIONI TAKAMITSU MURAOKA, BEZALEL PORTEN, A Grammar of Egyptian Aramaic (G. Garbini) ........ 207 H. ÇAMBEL, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions (Fiorella Scagliarini) ........................ 208 HERMANBEHRENS, Die Ninegalla-Hymme. Die Wohnungnahme Inannas in Nippur in altbabylo- nischer Zeit (Stefano Seminara) ................................................................................................ 213 M. COOPERSON, Classical Arabic Biography. The Heirs of the Prophet in the Age of al-Ma’mu¯n (Biancamaria Scarcia Amoretti) .................................................................................................. 218 États, sociétés et cultures du monde musulman médieval (Biancamaria Scarcia Amoretti) ..... 220 FLORIANSOBIEROJIbn Haf¯ıf asˇ-Sˇ¯ıra¯z¯ıund seine Schrift zur Novizenerziehung (Kita¯b al-Iqtisa¯d) (Samuela Pagani) ...¯.................................................................................................................˙..... 221 A.M. EDDÉ’ La principauté Ayyoubide d’Alep (Biancamaria Scarcia Amoretti) ........................ 223 A. R.LALANI, Early Shica Thought. The Teaching of Ima¯m Muhammad al-Ba¯qir (Biancamaria Scarcia Amoretti) ........................................................................˙................................................. 225 MIHAIMAXIM, L’Empire Ottoman au Nord du Danube et l’autonomie des Principautés Roumai- nes au XVIe siècle. Études et documents (Giuseppe Cossuto)........................................... 227 PÁLFODOR, In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics and Military Adminis- tration in the Ottoman Empire (Giuseppe Cossuto) .............................................................. 229 R. SHAMIR, The Colonies of Law. Colonialism, Zionism and Law in Early Mandate Palestine (Lu- cia Rostagno) ............................................................................................................................... 233 C. POUJOL, Le Kazakhstan (Ciro Lo Muzio) .................................................................................. 236 Mir’a¯t al-asra¯r by Shaykh ‘Abd al-Rahma¯n Chisht¯ı. Urdu¯translation form Persian and introduc- tion by Mawla¯na¯ Wa¯hd Bakhsh˙ Saya¯l Sa¯bira(Fabrizio Speziale) ........................................ 237 PREM CAND, I racconti di˙ Tolstoj, (Giorgio ˙Milanetti) ................................................................. 241 L. ALSDORF, Kleine Schriften: Nachtragsband, herausgegeben von Albrecht Wezler (Paolo Daffinà) ........................................................................................................................................ 244 E. FRANCO, K. PREISENDANZ, Beyond Orientalism. The Work of Wilhelm Halbfass and its Impact on Indian and Cross-cultural Studies (Federico Squarcini) ................................................... 248 VALDOFERRETTIe GIANCARLOGIORDANO, La rinascita di una grande potenza. Il rientro del Giap- pone nella società internazionale e l’età della Guerra fredda (Daniela Tozzi Giuli) ........ 250 SCHEDE BIBLIOGRAFICHE E. LEUMANN, Kleine Schriften, herausgegeben von Nalini Balbir (Paolo Daffinà) .................... 255 B. PLUTAT, Catalogue of the Papers of Ernst Leumann in the Institute for the Culture and His- tory of India and Tibet (Paolo Daffinà) ................................................................................. 256 LIBRI RICEVUTI............................................................................................................................ 259 SUPPLEMENTI M. PRAYER, The «Gandhians» of Bengal. Nationalism, social reconstruction and cultural orientations 1920-1942 [1] 1 RICERCHE SULLA SCRITTURA EGIZIA – V APORIE DELLA NOTAZIONE LINGUISTICA EGIZIA NEL III E II MILLENNIO A.C. La scrittura geroglifica è il cardine della scrittura egizia, mentre la scrittura ieraticaèricalcata su di essa, pur assumendo proprietà individuali, che variano nei diversi periodi e contesti di applicazione. La scrittura egizia costituisce un sistema logico originale, che si definisce nella molteplice varietà delle sue applicazioni. Alla sua base stanno i «logogrammi», ossia segni direttamente aderenti ai vocaboli, tantonelle loro componenti fonetiche quanto in quelle semantiche. A causa diciò i logogrammi per principio possono ricalcare una unica lingua, ap- punto quella in cui determinate proprietà fonetiche e semantiche coinci- dono. Nondimeno i logogrammi sono contraddistinti da una spiccata polisemia, laddove occorre tenere distinti il funzionamento della scrittura egizia nell’età arcaica (IIImillennio) e i suoi adattamenti seriori, segnatamente nel I millennio a.C., dove si riscontrano contaminazioni e reazioni rispetto alle altre scritture adoperate nell’area.La polisemia dei geroglifici nei templi tolemaici è un feno- meno che nasce dalla relativizzazione linguistica (dal II millennio). La polisemiadei logogrammi si esercita tanto con differenze di lettura (es. mr :∫∫b, ma in ieratico si distinguono con due segni peculiari; =sb∫∫: wnw(t) : dw∫∫), quanto con differenze di significato (es. sb∫∫ = «insegnare», «porta»). Ad essa corrisponde la polifonia dei fonogrammi: =∫∫ (r, l), e la poli- grafia dei suoni: l = [∫∫], [n], [r], [nr]. È talora in- certo se si tratti di polifonia o di poligrafia o di effettivi mutamenti fone- tici, come nel caso di h scritto sˇ nei Testi delle Piramidi. Si sono suppo- ¯ sti mutamenti non solo nel tempo (come t > t, notato con due caratteri ¯ diversi), ma anche nello spazio, senza che ciò comporti l’adozione di un carattere diverso (es. d > », notati entrambi con lo stesso carattere 2 Alessandro Roccati [2] per [»])1. La polisemiae polifonia dei logogrammi possono altresì esser connesse ad alloglossia, ma solo in quanto questa venga integrata nel sistema linguistico primario. m∫∫∫∫, ad Asiut vale ptr «vedere» (Urk.VII 66,11)2 n (negazione), ad Asiut vale b (negazione). Ciò richiamail carattere composito dell’egiziano (come di ogni lingua vei- colare), quale si palesa dalla presenza di allotropi lessicali come «contare»: ∫ıp, hsb, tn. B. van de Walle, Mélanges Vercoutter, Paris 1985, 366 nota 9 ∫ır : »n; ˙ ¯ sdm: ∫ıdn.Tale varietàè piegata ad un gioco stilistico, per esempio nei Testi delle ¯ Piramidi: 256a (sk : tm«annientare»), 258 b (qm∫∫ : ms«creare»), 259 a (m∫∫ : ptr «vedere»), mediante l’accostamento dei sinonimi. Nondimeno la creazione di valori fonetici alternativi è anche dovuta a ri- flessioni speculative,ad esempio nel caso di (lingua), che accanto al valore proprio ns, rende (dal Medio Regno) anche mr (< ∫ımy-r: «quello che sta nella bocca», lingua è maschile in egiziano). Tale apertura giustifica la notazione di alterazioni fonetiche suben- tranti: AR h > sˇ ¯ MR tw > tw ¯ npr > nfr (dio del grano) -t > 0. L’equiparazione delle due sibilanti, s, e z, a partire dal regno di Sesostri I,può significare una effettiva assimilazione dei due suoni, le cui nota- zioni, che si duplicano ora vicendevolmente, divengono esempi di poligrafia. Prescindendo dal processo storico, che potrebbe avere portato ad una fusione di duesibilanti diverse, si potrebbe però anche ravvisare nel fenomeno un caso di polifonia, ossia e renderebbero, dall’età di Sesostri I in poi, indiffe- rentemente tantosquantoz, esattamente come e varianti potevano rendere tantorquantol. Si tratterebbe in tale modo di una semplificazione del sistema fonetico nellagrafia. Inoltre il fatto che esista un carattere per esprimere un de- terminato suono (es. = d, = r) non impedisce che, per lo meno in determinate condizioni, sia adoperato un altro carattere per rappresentare ap- parentemente lo stesso suono: [r] = d, [∫∫] = r. 1 H. SATZINGER,Egyptian in the Afroasiatic Frame: Recent Egyptological Issues with an Impact on Comparative Studies:Afroasiatica Neapolitana.«Studi Africanistici. Serie Etiopica» 6. Istituto Universita- rio Orientale,Napoli 1997, 27-48: 27-33; IDEM,Egyptian»ayin in variation withd: Ling.Aeg. 6 (1999) 141-151. Si potrebbe anche supporre che all’origine vi fosse un «clic». 2 Cfr. E.EDEL, Die Inschriften der Grabfronten der Siut-Gräber in Mittelägypten aus der Hera- kleopolitenzeit (Abhandlungender Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 71), Opla- den 1984, p. 87-88. [3] Ricerche sulla scrittura egizia - V 3 L’equiparazione di s e z è di carattere secondario come si evince dall’uso dei logogrammi,che conservano parzialmente la distinta distribuzione origina- ria in rapporto alle sibilanti. Così /ms non si adopererà normalmente nel gruppo originario mz (ad esempio in mzh «cocco- ˙ drillo». Per converso,come gli stessi logogrammi possono esprimere diversi valori fonetici (es. :mre∫∫b), e diversi logogrammi possono esprimere gli stessi va- lori fonetici (es. mr: , , ), così i valori portati dalle unità minime (i cosiddetti«segni unilitteri»), nella loro varietà, si ripropongono nei segni con natura foneticacomplessa. La loro peculiarità risiede nella proprietà che le pos- sibilità divariazione si applicano non solo al segno (geroglifico e per lo più cor- rispondente ieratico,es. =gens(t), e =n), ma che lo stesso suono identificato in modo convenzionale nella trascrizione in alfabeto latino a guisa di un «carattere», può ricoprire una molteplicità di valori. Questa molteplicità si applicaegualmente ai segni complessi di cui il «carattere»è componente. Ad esempio, posto che «r» vale «r», «l», «d», tale polivalenza si riscontra al- tresì nei segni complessi di cui il carattere «r» ( ) è dato come compo- nente: «»pr», che rende il semitico »abd3; ns, che nel significato «lin- gua» riproduce certamente ls, cfr. copto . In tale molteplicità si osserva una differenza di frequenza tra la scelta dei valori, laddove solitamente uno di essi tende a predominare e ad escludere successivamente gli altri. Quando ilsistema volle precisare il valore fonetico effettivo, poté agire tanto sulla variazionedei caratteri: ad esempio «l» poteva esser reso sia con∫∫, sia conn, sia conr,ossia possedeva una poligrafia – sia mediante il cumulo dei caratteri:nr (e forse∫∫r) =l,cfr.twper notare «t» effettivamente pronunciata. Per converso l’uso sistematicoe regolare di un determinato carattere non è di per se garanzia di un organico e coerente valore fonologico, anche a prescindere dai mutamenti diacronici (si veda il caso di «»pr», che rende egualmente»abd). Tale facoltà concerne indubbiamente i logogrammi che nel tempo subi- rono alterazioni fonetiche, come sdm > sdm.Essa si riscontra anche relati- ¯ vamente aisingoli caratteri, ad esempio tquando >tpuò valere sia come ¯ t, siacomet, tanto che nella XI dinastia si aggiunge un tratto diacritico per di- ¯ stinguere il valore originario ( ). L’alternamento dei valori può pertanto variare nellediverse fasi storiche, generando o sopprimendo possibilità alterna- tive. Non è possibile dire quanto tale situazione debba ad esigenze orali, ma essa si presenta connaturata al sistema grafico e non dipende necessariamente 3 Tesi diO. Rössler (1966), confermata apud TH. SCHNEIDER,Die semitischen und ägyptischen Na- men dersyrischen Sklaven des Papyrus Brooklyn 35.1446 verso:UF 19 (1987) 255-282: 258-260. Le obie- zioni diJ. OSING,Zum Lautwert von [∫∫] und[»]: SAK 24 (1997) 223-229, si riferiscono ad altre proposte del Rössler. In tutti i casi si discute per l’identificazione di un valore univoco dei singoli grafemi geroglifici. 4 Alessandro Roccati [4] da esigenzefonologiche. Ne deriva che la scrittura egizia non solo prescinde dai principi alfabetici, ma neppure si può considerare fonematica. Il suo sistema consiste nelladefinizione di caratteri che hanno anzitutto un valore distintivo a livello grafico, e solo secondariamente corrispondono a suoni distinti della lin- gua (ad esempio = sdm e sdm). ¯ Vi si può confrontare, come lontana analogia, a titolo esplicativo, feno- meni dellagrafia dell’italiano, come il doppio valore di «c» in casa e in cena, di «s» incasa e in rosa, di «z» in zigomo e in rozzo, ecc., che ancora son dovuti ad eventi di fonetica storica. Le aporienella notazione del sistema fonetico egizio sono quindi di ordine tanto sincronico quanto diacronico. Esempi: Fase antica Il carattere∫∫ rende r fino al MR, poi diviene 0. Il caratterenrendenel, cfrns«lingua», semiticolisan, copto ; copto < n∫∫ «articolo plurale». Il carattere r rende r, cfr r «bocca», copto . Lo scambio dei caratteri r, n,∫∫ rivela il fonema l. Il carattererrended, cfr»prche rende semitico»abd(doveprende semi- tico b). Il carattere p rende p, cfr copto < p∫∫. Il carattere della negazione ( ) può esser letto n e b4. Fase nuova Il carattere b (scritto bw) rende m (oltre a b), cfr bwpw.f (< n p∫∫.f), copto . Il carattere∫∫ vale 0: scrittura etimologica o, a volte, impropria. Il gruppo tw rende t (effettivamente pronunciato: dal MR) a seguito di evoluzione fonetica.Si attua quindi un procedimento per connotare nella scrit- tura suoniche non si pronunciano più, e altri che, contro le attese, sono conser- vati nellapronuncia effettiva. Si ricordi la grafia r∫ı= r > ∫ı/0. Tale polivalenza è già stata postulata a proposito di una eventuale notazione vocalica5. Le cosiddette aporie non discendono probabilmente da motivi di ordine fonetico, ma debbon trovare la loro giustificazione nella dinamica dello svi- luppo delsistema, che è altra da quella dei requisiti fonetici dell’«alfabeto», pur interferendo naturalmente anche con esigenze propriamente fonetiche. Ed è 4 J.J. CLÈRE,L’ancienneté des négationsàb initial du néo-égyptien: MDIK 14 (1956) 29-33; H.G. FISCHER: WZKM57 (1961) 70-71 nota 29; cfr. P. LACAU,Sur le système hiéroglyphique, Cairo 1954, p. 17. 5 A. ROCCATI: La notazione vocalica nella scrittura geroglifica: OA 27 (1988) 115-126. [5] Ricerche sulla scrittura egizia - V 5 questa la ragione per scrivere nfr anziché npr «grano» nel II Periodo Interme- dio6, notare occasionalmente sdm per il più antico sdm, scrivere la desinenza ¯ della Ipers. sing dello pseudoparticipio.kw, e così numerosi altri esempi. Nello stesso tempo, quando troviamo scritto, ad esempio, »pr, dobbiamo ammet- tere chequesta grafia possa definire i fonetismi»pr(come i Khabiru > Ebrei?) e »bd (il semitico »abd «servo»). Tale indifferenzadel sistema verso la notazione fonematica complica sia gli spunti comparativi (dove non è automatica la corrispondenza tra tale carattere egizio e tale suono di altra lingua), sia i confronti diacronici all’interno dello stesso sviluppo linguistico egizio. Si comprende come gli Egizi stessi, quando volessero precisarela pronuncia fedele, almeno approssimativamente, di un vo- cabolo nel loro tempo ricorressero all’accostamento di omofoni. È questo uno dei procedimentiche si osservano nel Nuovo Regno per la scrittura di vocaboli non egizi (la cosiddetta scrittura sillabica, o di gruppo, termini entrambi non soddisfacenti), e che viene ampliato in età romana7. Ad Asiut, nelle iscrizioni del primo Medio Regno, si nota un numero inso- lito divalori inusuali, il che pone la questione della possibilità di scrivere varietà di lingua diverse da quella base. Es. l’occhio vale ptr anziché m∫∫∫∫, laddove ptr appare pur sempre come un vocabolo incluso nella lingua e desti- nato adiffondersi; in neoegizio esso risulta prevalente. Dietro a ciò vi è la que- stione della composizione linguistica dell’Egitto, tanto molteplice quanto in- consapevole, quale è riflettuta dalla lingua codificata nella scrittura. Essa si av- verte anchenella presenza diacronica di allotropi (∫»∫ : neoeg.dy, cfr. Loprieno e Kammerzell8). La scrittura potrebbe anche occultare l’esistenza di tali allo- tropi, mediante valori distinti conferiti allo stesso carattere; in tale caso il pas- saggio al neoegizio presenta una vera e propria struttura grafica alterna- tiva9. Si distinguono quindi tre gradi di rappresentazione fonetica: 1. Il logogramma cambia struttura a seguito di mutamenti fonetici, es. sdm >sdm. ¯ 2. Si cambia con un logogramma rispondente alla nuova e diversa realtà fonetica, es. npr > nfr. 6 P. VERNUS,A propos de la fluctuation P/F:Form und Mass (Fs. Fecht), Ägypten und Altes Te- stament 12,Wiesbaden 1987, 450-455. Agli esempi dati perNfr = Npr, si aggiunga KRII 74, e Medinet Habu II116, 5, cfr. Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens (Festschrift Stadelmann), Mainz 1998, p. 267, ed egualmente Wb II 261, 4-5 (copto ). 7 J. OSING,Hieratische Papyri aus Tebtunis, Carlsberg Papyri 2 (CNI Publications 17), Copenha- gen 1999. 8 Festgabe Westendorf, Göttingen 1994, p. 127 nota 40. 9 Cfr. nota 1. 6 Alessandro Roccati [6] 3. Siprocede a una diversa determinazione dei valori fonetici dei caratteri (unità) componenti, es. »pr = »abd. Tale versatilità dovrebbe concernere anche la considerazione delle vocali, sia nella loro assenza dalla scrittura, sia nella possibilità di accoglierle nel si- stema grafico. Così il segno ∫ıpoteva renderea, i,e ancheu, come dimostra la grafia if, variante di∫ı(w).f, *uf, copto «carne». Ciò indica la possibi- lità che, nell’Antico Regno, tale valore intervenisse nella prima persona singo- lare dello pseudoparticipio.k∫ı(*.ku), mentre successivamente parve utile adot- tare lagrafia*.kwper designare lo stesso valore*.ku. Se questa spiegazione, che rovescia quellatradizionale10,è valida, confermerebbe che talora furono le con- venzioni grafiche a mutare, e non le strutture fonetiche (si veda quanto già detto sopra su s/z). È infine verosimile che tale flessibilità dei suoni operasse a livello di sillaba11. È stato osservato12 che la notazione fonetica di elementi grammaticali, e pertanto non aventi natura di logogrammi, è interconnessa con la struttura fo- netica interna dei logogrammi cui si applica. Ad esempio = ntr, = ¯ ntry: intale caso la desinenza-yè specificata non mediante un simbolo proprio, ¯ ma attraverso l’aggiunta del complemento fonetico [r] a ntr. Ne deriva che la ¯ pronuncia reale possiede implicazioni per la specificazione di elementi aggiunti, e chela notazione di questi non è dovuta semplicemente ad esigenze grammati- cali. Siveda ad esempio la (non) scrittura del pronome personale suffisso∫ınelle iscrizioni dell’Antico Regno. Analogamente si deve forse spiegare la scrittura costante della terminazione femminile -t anche quando essa non era notoria- mente più pronunciata: distinzione del genere, e soprattutto della struttura in- terna. Non si tratta quindi soltanto di un residuo dovuto a grafia storica. Fatti del genere possono esser rivelati dallo studio di assonanze non apparenti a li- vello di scrittura13. La polisemiadei logogrammi è ammessa anche a livello puramente seman- tico, ad esempio nei procedimenti di animazione: con braccia: , con gambe: con altri movimenti: , 10 EDEL, Altäg. Gram. § 881. 11 S. YEIVIN,The Sign [∫∫] and the True Nature of the Early Alphabets: Ar.Or. IV (1932) 71-78: 75: «The Egyptians never adopted the alphabetic writing for the very simple reason that they did not know it». 12 W. Schenkel,in Quaerentes Scientiam (Festgabe Westendorf), Göttingen 1994, p. 165, cf. J. Osing, Nominalbildung, Mainz 1976, p. 309-320. 13 A. ROCCATI,Scritture ellittiche in egiziano: VO 7 (1988) 35-38; cfr. W. GUGLIELMI,Funktionen des Wortspiels: Fs. Westendorf, Göttingen 1984, I, 491 ss.; C.T. HODGE,Ritual and Writing: an inquiry into theorigin of Egyptian Script: Linguistics and Anthropology (Studies in honor of C.F. Voegelin), Lisse 1975, p. 331-350; E. EDEL: Enchoria 18 (1991) 179 ss.; RdE 47 (1996) 171.
