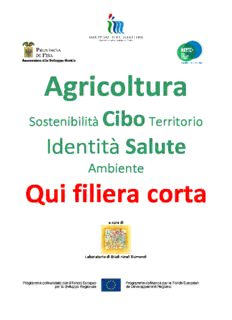
Qui filiera corta PDF
Preview Qui filiera corta
Assessorato allo Sviluppo Rurale Agricoltura Cibo Sostenibilità Territorio Identità Salute Ambiente Qui filiera corta a cura di Laboratorio di Studi rurali Sismondi Assessorato allo Sviluppo Rurale Coordinamento e testi a cura di Laboratorio di Studi rurali Sismondi in collaborazione con La presente pubblicazione Agricoltura, Sostenibilità, Cibo, Territorio, Identità, Salute, Ambiente. Qui filiera corta rientra nell’ambito di una serie di iniziative promosse dalla Provincia di Pisa, Assessorato allo Sviluppo Rurale, a sostegno delle imprese agricole del territorio provinciale e delle produzioni locali. La pubblicazione, finanziata nell’ambito del Progetto transfrontaliero Marte+, è stata curata dal Laboratorio di Studi rurali Sismondi. Coordinamento a cura di Silvia Innocenti. Testi a cura di Leonardo Ferrante. Si ringrazia la Regione Toscana e l’Agenzia Regionale di Sanità per i contenuti relativi alla Piramide Alimentare Toscana e per la concessione d’uso del logo. Si ringrazia la dr.ssa Giusy d’Urso, biologa nutrizionista, per i contenuti relativi alla stagionalità delle produzioni. 2 Un’alleanza tra città e campagna L’agricoltura è un settore strategico per qualunque paese del mondo, non solo per il valore economico che esprime, ma perché è alla base della salute delle persone e della qualità della vita. E’ urgente sviluppare un adeguato avanzamento culturale sull’importanza dell’agricoltura, sui modelli di agricoltura, sui servizi e sulle funzioni di interesse collettivo che essa è in grado di svolgere; tornare a riappropriarci della conoscenza di chi produce il cibo che mangiamo e di come lo produce; ampliare gli spazi di libertà di scelta per noi cittadini; riaffermare con forza la principale funzione dell’agricoltura: produrre il nostro cibo. E’ una questione di salute e di qualità della vita dei cittadini, non soltanto sul piano ambientale. I processi di internazionalizzazione rischiano di estraniare sempre più il consumatore dalle fasi di produzione, dalla provenienza, stagionalità e qualità degli alimenti, penalizzando, di conseguenza, un settore molto delicato, che costituisce, per definizione, una risorsa endogena per qualunque territorio, non facilmente replicabile. Il modello dominante, quello agricolo industriale, che si è imposto negli ultimi decenni, ha creato una forte distanza tra produzione e consumo. Anziché valorizzare l’agricoltura familiare e locale, le regole della globalizzazione applicate all’agricoltura hanno incentivato un modello fortemente energivoro, orientato al mercato, “fatto per vendere” in grandi quantità, in qualunque stagione, con evidenti contraddizioni e conseguenze sul piano sociale ed ambientale in termini di inquinamento (basti pensare a quanti chilometri percorrono i cibi per arrivare sulle nostre tavole!), consumo delle risorse, perdita della biodiversità, progressiva riduzione dei margini di guadagno per le imprese, per non parlare del complesso tema della proprietà intellettuale dei semi, che meriterebbe uno specifico approfondimento. Già a metà degli anni Novanta i prezzi alla produzione offerti ai contadini erano ridicoli, qualcosa di umiliante per chi ben sa quanta fatica è necessaria a far crescere mele e pere che abbiano delle qualità. Solo per renderci conto: ogni euro di spesa alimentare si compone mediamente di 60 centesimi per la distribuzione e il commercio, 23 centesimi per la trasformazione e solo 17 centesimi per la produzione! Il modello toscano di agricoltura ha da sempre offerto alla città prodotti orientati verso la qualità, ma resta tuttavia fortemente esposto agli effetti della globalizzazione. L’agricoltura della provincia di Pisa ha intrapreso ormai da tempo un percorso di adeguamento improntato sulla ricerca di mercati di qualità, sulla differenziazione, sulla creazione di valore e sulla diversificazione produttiva. Sotto questo profilo, le imprese hanno saputo sfruttare le potenzialità derivanti dal flusso turistico, da una qualificazione della domanda dei consumatori locali, da una crescente vivacità e disponibilità alla collaborazione tra imprese e con le Amministrazioni locali, che hanno incoraggiato la nascita di progetti comuni e iniziative collettive (mercati locali, botteghe di produttori, GAS, progetti di informazione e sensibilizzazione nelle scuole). A partire da queste azioni e all’interno di un quadro più ampio di attività sulle quali siamo impegnati come Amministrazione Provinciale a sostegno delle imprese agricole del territorio provinciale e delle produzioni locali, l’Assessorato allo Sviluppo Rurale ha recentemente intrapreso, con il supporto tecnico-scientifico del Laboratorio di studi rurali Sismondi, un percorso per la definizione, strutturazione e successiva adozione di un Piano del Cibo della Provincia di Pisa. Con esso ci proponiamo di mettere in relazione e di costruire quella rete di reciproca “utilità” tra i bisogni delle comunità locali e la capacità produttiva del sistema locale, facendo emergere quei legami (ora non visibili), allo scopo di rafforzare l’efficacia delle iniziative e rispondere a due esigenze: da una parte, la tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini; dall’altra, la strutturazione di un modello economico locale soddisfacente per le aziende dei nostri territori. Con questi obiettivi abbiamo condiviso con numerosi soggetti (ricercatori, docenti, educatori, operatori della salute, associazioni e società civile, soggetti economici, amministratori locali) la Carta del cibo e la sua Strategia. Questi documenti gettano le basi dell’agenda collettiva verso la realizzazione del nostro Piano del cibo, il cui intento è quello di comprendere e far comprendere il legame che esiste tra benessere della 3 popolazione, salute e igiene dell’alimentazione, gestione dei suoli, valorizzazione delle produzioni locali e creazione di economie di territorio e di nuova occupazione nelle campagne. L’idea di agricoltura che sottende a questa impostazione affonda le sue radici nella cultura e nella civiltà contadina e nei valori di cui è portatrice: rispetto dei cicli e tempi di produzione, stagionalità, senso di comunità e solidarietà; un’agricoltura fatta da aziende che, detto in altri termini, sentendo la responsabilità del proprio ruolo nella società, sono in grado di produrre beni pubblici, oltre che beni privati. Ne consegue la necessità da parte delle istituzioni pubbliche di uno sguardo attento e conseguente sulle scelte di governo del territorio e sulla pianificazione urbanistica, uno degli strumenti essenziali per costruire qualità sociale e ambientale, se la collochiamo, come merita, nel quadro di politiche e azioni di governo integrato del territorio improntate a realizzare la sostenibilità dello sviluppo e difendere la terra dalle speculazioni (fondiarie, energetiche, edilizie…). Un’alleanza tra città e campagna è, quindi, la sfida necessaria ed auspicabile soprattutto ai fini della tutela delle produzioni di cibo, delle risorse ambientali e del paesaggio. Essa è innanzitutto un processo culturale, che presuppone il riconoscimento reciproco di ruolo e servizi, che non sono in competizione tra loro. Occorre operare un cambiamento necessario dal punto di vista culturale e produttivo, lavorando per costruire le condizioni per la definizione di un nuovo “patto” tra consumatori, produttori e altri soggetti, ricostruendo al contempo le condizioni per un rilancio economico delle imprese e dell’intero settore. La filiera corta con le sue potenzialità di azione diventa un nodo centrale nella ricostruzione di un positivo e proficuo rapporto e di una nuova alleanza tra città e campagna. Con questa pubblicazione, vogliamo fornire al cittadino-consumatore uno strumento in più per riflettere su questi temi e per poter fare la propria scelta. Giacomo Sanavio Assessore alla Programmazione territoriale e Sviluppo Rurale della Provincia di Pisa 4 Sommario “L’uomo è ciò che mangia”: semplice, ma non banale Pag. 5 Perché tornare a scegliere la filiera corta? Pag. 7 Filiera corta ed educazione alimentare: la Piramide Alimentare Toscana (PAT) Pag. 9 Ad ogni stagione, i suoi frutti Pag. 11 Filiera corta e sostenibilità ambientale: l’agricoltura ecocompatibile Pag. 11 I luoghi della filiera corta Pag. 12 Iniziative di filiera corta in Provincia di Pisa Pag. 16 La tradizione culinaria della provincia di Pisa Pag. 17 Appendice: La Carta del Cibo della Provincia di Pisa Pag. 20 5 “L’uomo è ciò che mangia”: semplice, ma non banale Un famoso motto recita che “l’uomo è ciò che mangia”1. Eppure – se ci fermiamo un attimo a riflettere - questa affermazione nella sua semplicità, apre uno scenario molto più complesso. Occorre infatti tenere ben presente che il cibo non è solo “ciò che mettiamo in pancia”, ma la sua assunzione prevede un atto, il “mangiare”, profondamente composito, con una valenza sì nutrizionale, ma anche ambientale e simbolica. Questo significa in parole povere che l’essere umano ha fondamentale bisogno di alcuni nutrienti per sopravvivere, ma da sempre la cultura influisce su quello che consideriamo appetibile/ripugnante. Un esempio semplicissimo: forse la totalità di chi legge proverà senso di disgusto al pensiero di mangiare insetti o cani. Eppure in alcuni Paesi è reputato “normale” e “buono”, mentre ve ne sono altri in cui la sola idea di consumare carne di maiale o bovino può creare sgomento! Eppure, da un punto di vista meramente nutrizionale (non etico, non religioso, non culturale) fermandosi cioè alla sola possibilità fisiologica, nulla impedirebbe di assumere ciascuna di queste forme di vita. Che cosa ci dice questo? Che per tanto tempo, in rapporto al cibo, è esistito un equilibrio tra due caratteristiche (necessità nutrizionali vs. cultura) fondato su una terza peculiarità fondamentale: ciò che l’ambiente era naturalmente capace di offrire. Il nostro era, cioè, un mondo fatto di tantissimi piccoli sotto- mondi che si fondavano sul principio: L’essere umano può mangiare ciò che può produrre secondo l’ambiente in cui vive, tenendo conto del soddisfacimento delle proprie esigenze fisiologiche, all’interno di un sistema di valori, che muta,però, a seconda del contesto e in base al quale prediligerà un cibo rispetto ad un altro. Quello che abbiamo appena descritto altro non è che l’equilibrio che porta, oggi, alla rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo del cibo (ma non solo). Come già anticipato, il perno di questo sistema è la dinamica locale: si produce ciò che il sistema naturale permette che si produca (in quello spazio particolare ed in una stagione precisa (!). La filiera corta non è, quindi, un concetto nuovo, ma un approccio innovativo che richiama gli equilibri esistenti per millenni, quando il cibo era prodotto principalmente per soddisfare il bisogno locale. Oggi si parla di filiera “corta” (o “breve”) perché i passaggi dall’origine del cibo alla bocca di chi lo mangia sono pochi, sia in termini di scambi fatti, sia in termini di chilometri percorsi. La filiera corta si pone invece in contrapposizione con la logica che ha guidato i mercati e che ha portato al modello economico in cui tuttora viviamo. Lo sviluppo dei trasporti e dei flussi di informazioni hanno reso e 1 La massima si deve al filosofo tedesco Feuerbach (“der Mensch ist was er ißt”). 6 rendono possibile muovere quantità enormi di prodotti, in tempi rapidissimi da un lato all’altro del mondo, che, a poco a poco, si fa uno. E’ la logica della “filiera lunga”: L’essere umano può mangiare quello che il sistema dei trasporti gli mette a disposizione: non più secondo l’ambiente in cui vive, ma secondo logiche allargate e globali. Il suolo non è più chiamato a soddisfare le diverse esigenze della popolazione vicina, ma a produrre anche un solo bene per chi è distante migliaia di chilometri. I valori legati al cibo non sono più territoriali, ma decisi dagli equilibri del mercato e da chi vi opera. L’aggettivo “lunga” si riferisce, quindi, sia ai chilometri che il cibo percorre prima di essere mangiato, sia ai numerosi passaggi che il cibo fa durante il suo viaggio. Ma la distanza può riguardare anche altre caratteristiche, per mancanza di informazioni sulla composizione, sulla provenienza e sulle ricadute sulla salute rispetto ad un cibo che diventa completamente estraneo e lontano da qualsiasi territorio. Oggi ciò che mettiamo sulle nostre tavole è regolato in gran parte da questo sistema, ma negli ultimi anni in modo sempre più pressante, in forma organizzata o spontanea, si sta diffondendo “dal basso”, incontrando l’attenzione e la sensibilità di Istituzioni, la richiesta di un ritorno alla filiera corta, a partire dalla consapevolezza che il cibo non è affatto e non può essere una merce come le altre, ma un bene necessario da trattare con categorie diverse. È importante sottolineare che tale scenario non è assolutamente “uno stato di grazia”; anzi è stato nel corso della storia all’origine di conflitti e di contraddizioni profonde (basti pensare alle carestie che affamavano milioni di donne e uomini). La valenza positiva che viene data oggi sottende, quindi, un lavoro profondo di rielaborazione e trasformazione dei conflitti, cercando di tornare a quell’equilibrio, ma attraverso l’impegno collettivo a costruire sistemi diversi basati sulla ricerca di un mondo più “giusto”. Ma di questo avremo modo di parlarne in seguito. Se è vero allora che “siamo quello che mangiamo”, parlare di cibo significa dunque discutere di economia, di società, di ambiente, di salute, di diritti, di valori e del modello di produzione e consumo che, coscienti o meno, volenti o nolenti, scegliamo. 7 Perché tornare a scegliere la filiera corta? La filiera lunga non ha risolto alcuni dei punti nodali riguardo a problematiche sociali, economiche e ambientali. Sono sotto gli occhi di tutti, infatti, i limiti del modello economico basato (anche) sulle filiere lunghe e che ha portato ad uno scenario ricco di contraddizioni: da una parte la crescita della popolazione mondiale che non ha possibilità di accesso al cibo o ad un’alimentazione adeguata, dall’altra l’aumento dell’obesità, delle malattie o dei disturbi legati alla sovra alimentazione, oltre che alle problematiche relative allo smaltimento degli scarti prodotti e alla trasparenza dei processi produttivi. La “filiera corta”, al contrario, è quel modello di produzione e di consumo basato sulla relazione tra territorialità, prossimità dei prodotti e del consumo, pratiche di socializzazione, salvaguardia del lavoro e giusta remunerazione per chi è impegnato nel settore agroalimentare, rapporto fiduciario tra produttore e consumatore. Per capire perché la filiera corta può essere una “strategia vincente” per territorio, produttori e cittadini, occorre intanto costruire nuove definizioni di “convenienza”, “qualità” e “identità”, che mettano al centro i benefici sulla salute individuale, sulla società e sull’ambiente. Filiera corta … per il territorio Come abbiamo visto, la filiera lunga rompe l’equilibrio fondato sull’ambiente e non si interroga sulla consumo e la capacità di rigenerazione delle risorse e delle specificità territoriali. Ovviamente questo modo di gestire la natura ha una “data di scadenza”, che questo modello finge di non vedere. Eppure non ce lo possiamo più permettere! In realtà, è fondamentale, ai fini della salvaguardia e della custodia della Terra, dei piccoli sistemi locali e della loro identità, recuperare un equilibrio basato sul limite naturale, non solo per una questione etica e valoriale, ma anche nella consapevolezza dell’“effetto farfalla” che riguarda il nostro mondo: sappiamo infatti che modifiche da una parte della Terra possono condizionare fortemente uno spazio distante migliaia di chilometri. Tutti siamo chiamati a questa corresponsabilità, intervenendo anche contro la lotta agli sprechi. Evitare lo spreco di territorio e di risorse attraverso la riscoperta delle peculiarità locali è una delle ragioni più forti per cui scegliere il circuito breve. Filiera corta … per i produttori Per i produttori, il passaggio alla filiera corta è conveniente sia a livello economico, in quanto modello in grado di garantire una giusta remunerazione, sia a livello di creazione e consolidamento di legami di fiducia con i consumatori. La sproporzione tra il prezzo pagato al produttore e quello pagato dal consumatore si gioca tutta nei passaggi che il cibo compie da un nodo all’altro della filiera lunga. Viceversa, un canale diretto capace di avvicinare il mondo della produzione a quello del consumo e quindi, “contrarre” la filiera, prevede un vantaggio vicendevole, che nel caso del produttore significa anche poter ricevere una remunerazione più equa. Il rapporto di prossimità, di vicinanza relazionale e territoriale permette di “stringere” legami reali tra persone reali. Il profitto non è infatti il solo, o il principale, obiettivo da perseguire. Sapere a chi va il frutto del proprio lavoro è qualcosa di importante per il produttore, anche al fine di recuperare una propria identità e dignità e venir fuori da una sorta di confinamento che lo vuole oggi parte di “ingranaggio industriale”. Filiera corta…per i cittadini consumatori Numerosi sono i vantaggi dai sistemi a filiera corta anche per quelli che ormai in molti chiamano cittadini- consumatori, ossia noi tutti. L’anteporre la “cittadinanza” al “consumo” sottintende che il cibo prevede dei 8 diritti (ad un’alimentazione sana, sicura e adeguata), ma anche dei doveri (evitare gli sprechi e preservare le risorse). Oggi, coniugandosi in modi diversi a seconda del contesto, il “diritto al cibo” è evocato in tutto il mondo e spesso passa attraverso i canali della richiesta di giustizia sociale, specie dove il presente sistema crea squilibri profondi. Quanto alla nostra parte di mondo, il passaggio da un consumatore indistinto ad un cittadino consapevole e responsabile che conosce la storia di ciò che “mette in pancia”, si gioca nel legame di fiducia che si stabilisce con il produttore e nel riscoperto legame con il territorio e sue peculiarità. Stiamo parlando quindi di un diritto di cittadinanza attraverso cui è possibile recuperare un‘identità singola e collettiva, che permette – anche in questo caso - di non essere identificati come massa indistinta. Vi è poi la certezza di mettere sulla propria tavola prodotti di stagione sempre freschissimi, coltivati secondo natura e non imballati, provenienti dal campo conosciuto distante pochi chilometri. È attraverso il rapporto di fiducia e la conoscenza diretta del produttore e dell’azienda che il cittadino consumatore trova le risposte anche in tema di sicurezza alimentare. Per esercitare i nostri diritti/doveri di cittadini consumatori, noi tutti siamo chiamati ad un profondo lavoro su noi stessi ed il legame con il cibo. Il sistema a filiera lunga ci ha abituati a credere che in ogni momento dell’anno sia possibile beneficiare di qualsiasi bene. Questo però, è oltre la soglia di sostenibilità dell’ambiente. Occorre quindi ridisegnare il nostro “pensare il cibo”, adeguando quanto più possibile la nostra domanda al ciclo naturale delle stagioni. Si tratta insomma di educarsi secondo i tempi e le possibilità della Terra, che sono comunque tante. Una nuova educazione deve passare da qui, impegnandoci anche a recuperare le ricette tradizionali che si fondano sull’equilibrio tra produzioni e territorio e capaci di esaltare naturalmente il gusto degli alimenti. Non si tratta quindi di “moda del momento”, ma di una necessità ambientale e collettiva! 9 Filiera corta ed educazione alimentare: la Piramide alimentare toscana (PAT) Abbiamo avuto modo di sottolineare in apertura come la filiera lunga non solo abbia falsato gli equilibri naturali, ma, mettendo come punto cardine il principio di mercificazione del cibo, ha finito col mettere in discussione anche l’accesso ai giusti nutrienti di cui l’essere umano, da sempre e per sempre, ha e avrà bisogno. La maggiore disponibilità di varietà e quantità di cibo ha, man mano, svincolato la routine alimentare dal territorio e dalla stagionalità delle produzioni, favorendo comportamenti scorretti (ipernutrizione e sedentarietà, ad esempio). Se “l’uomo è ciò che mangia”, di conseguenza ha bisogno di accedere a differenti nutrienti in quantità diverse ed in tempi diversi per stare bene. Ma come sapere cosa mangiare, ed in quali quantità? Cioè, come seguire una alimentazione adeguata? Sulla falsariga di altre esperienze, la Regione Toscana ha proposto una risposta semplice ed efficace: la “Piramide Alimentare Toscana” (PAT), stilata avvalendosi della competenza di attenti e validi ricercatori. Utilizzando il noto schema della piramide alimentare, la PAT indica non solo le corrette proporzioni dei cibi che non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta, ma inserisce nelle diverse categorie le eccellenze prodotte dal nostro territorio. Nel livello più basso, alla base della Piramide, sono rappresentati i cibi da consumare più spesso, mentre man mano che si salgono i gradini vengono indicati quelli da consumare con minor frequenza2. La caratteristica importante di tale modello è che abbina i bisogni fisiologici alla disponibilità di alimenti conforme alla territorialità regionale. Significa che il modello ci dice anche attraverso quali specifici alimenti della tradizione toscana possiamo seguire un’alimentazione corretta sia per il nostro corpo che per il nostro territorio. Leggendo la PAT a partire dal suo vertice (carni rosse, salumi e dolci), il territorio della nostra provincia può fornire alcune eccellenze, come il Mucco pisano e la Pecora pomarancina, passando poi, al quarto e al quinto gradino (pesce, carni bianche, uova, formaggi e patate) alla patata di Santa Maria a Monte, ai formaggi, come il pecorino toscano alle erbe aromatiche, il Pecorino del Parco di Migliarino-San Rossore, il Pecorino baccellone e il Pecorino delle Balze Volterrane (detto semplicemente pisano). Al terzo livello troviamo la frutta secca, i legumi e il latte. Tra le varietà del territorio che possono venire dalla filiera corta troviamo la Piattella pisana (un tipo di fagiolo) e il pinolo del parco di Migliarino – San Rossore. Il latte è disponibile anche attraverso i tanti distributori di latte crudo diffusi sul nostro territorio, all’interno di punti vendita nelle città, in forma ambulante durante i mercati o direttamente presso le stalle. 2 Informazioni tratte integralmente da www.regione.toscana.it/piramidealimentare/. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a questo indirizzo. 10
Description: