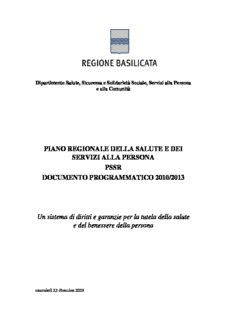
Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona PSSR Documento Programmatico 2010 ... PDF
Preview Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona PSSR Documento Programmatico 2010 ...
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità PIANO REGIONALE DELLA SALUTE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA PSSR DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2010/2013 Un sistema di diritti e garanzie per la tutela della salute e del benessere della persona mercoledì 23 dicembre 2009 mercoledì 23 dicembre 2009 2 INTRODUZIONE...........................................................................................................7 1. ANALISI DI CONTESTO.....................................................................................13 1.1 Il contesto istituzionale e normativo nazionale.......................................................13 1.2 Il contesto istituzionale e normativo regionale........................................................15 1.2.1 Il percorso di attuazione della riforma delle politiche sociali...............................15 1.2.2 Il processo di riordino del Sistema sanitario regionale.........................................16 2. ANALISI DEMOGRAFICA ED EPIDEMIOLOGICA..........................................19 2.1 Quadro demografico..............................................................................................19 2.2 Stato di salute.......................................................................................................25 2.3 La mortalità...........................................................................................................27 2.4 La morbosità..........................................................................................................29 2.4.1 Malattie infettive.................................................................................................29 2.4.2 Malattie croniche rilevanti per frequenza ed impatto...........................................30 2.4.2.1 Malattie cardio-vascolari..................................................................................30 2.4.2.2 Diabete............................................................................................................32 2.4.3 Tumori................................................................................................................33 2.5 Infortuni................................................................................................................37 2.5.1 Incidenti stradali.................................................................................................37 2.5.2 Incidenti domestici..............................................................................................37 2.5.3 Infortuni sul lavoro.............................................................................................39 2.6 Prevenzione...........................................................................................................41 2.6.1 Donne e maternità...............................................................................................43 2.6.2 Infanzia, età evolutiva e giovani..........................................................................44 2.6.3 Disabilità e non autosufficienza..........................................................................46 2.7 Gli anziani non autosufficienti...............................................................................46 2.8 Salute mentale e disabilità psichica........................................................................47 2.9 Tossicodipendenze.................................................................................................48 2.10 Popolazioni “fragili”............................................................................................50 2.10.1 Famiglie povere................................................................................................50 2.10.2 Immigrati ed esclusione sociale.........................................................................51 2.10.3 Comunità zingare..............................................................................................51 2.10.4. Prostituzione...................................................................................................52 2.10.5 Detenuti............................................................................................................53 2.10.6 Conclusioni.......................................................................................................54 3. LA PREVENZIONE GLOBALE E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE.........55 3.1 I Dipartimenti aziendali di Prevenzione..................................................................56 3.1.1 Dipartimento di prevenzione collettiva della salute umana..................................57 3.1.2 Dipartimento di prevenzione della sanita’ e benessere animale............................58 3.1.3 COMPETENZE Aziende Sanitarie Regionali....................................................59 3.1.3.1 Compiti e funzioni del servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica:.......59 3.1.3.2 Compiti e funzioni del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione:...........61 3.1.3.3 Compiti e funzioni del servizio medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro..........................................................................................................................62 3.1.3.4 Compiti e funzioni del servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro...........................................................................................................64 3.1.3.5 Compiti e funzioni del servizio sanità animale (Area A)...................................64 3.1.3.6 Compiti e funzioni del servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B):.........................................................................................................65 mercoledì 23 dicembre 2009 3 3.1.3.7 Compiti e funzioni del servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area c):...................................................................................................66 4. MACROLIVELLO TERRITORIALE.....................................................................74 Premessa.....................................................................................................................74 4.1. Il distretto della salute...........................................................................................78 4.1.1 Le funzioni.........................................................................................................80 4.1.2 L’organizzazione del Distretto............................................................................82 4.1.3 Gli strumenti di programmazione ed il ruolo del livello locale.............................83 4.1.4 Il modello distrettuale.........................................................................................86 4.2 Il Sistema dell’Assistenza primaria........................................................................89 4.2.1 L’Unità di Valutazione Integrata (UVI)...............................................................91 4.2.2 Presa in carico.....................................................................................................93 4.2.3 Il Responsabile del percorso assistenziale (CASE MANAGER)..........................94 4.2.4 Lo “Sportello unico di accesso ai servizi sociali e sanitari”.................................95 4.2.5 Le forme innovative dell'assistenza primaria da sperimentare sul territorio........101 4.3 ll sistema delle Cure Domiciliari..........................................................................105 4.3.1 Obiettivi e funzioni dell’assistenza domiciliare.................................................106 4.3.2 Livelli di intensità assistenziale.........................................................................107 4.3.3 Organizzazione dei servizi sanitari domiciliari..................................................110 4.3.4 Presa in carico e Piano di assistenza..................................................................113 4.3.5 Procedure per l'attivazione delle cure domiciliari..............................................115 4.4 Cartella Domiciliare Integrata..............................................................................116 4.4.1. Scheda di Rilevazione Assistenziale Domiciliare (RAD)..................................116 4.4.2 Sistemi di monitoraggio....................................................................................117 5. IL SISTEMA DELLA RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER UTENTI NON-AUTOSUFFICIENTI........................................................................119 5.1. Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali per Anziani......................................120 5.2 Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali per Disabili.......................................126 5.3 Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche.....................................131 5.4 Prestazioni nei Centri Residenziali per Cure Palliative / Hospice.........................135 5.5 Sistemi di monitoraggio.......................................................................................137 6. Il sistema extra-ospedaliero per la Riabilitazione e le Disabilità...........................139 6.1. Logiche generali della rete della Riabilitazione...................................................141 6.2 Rete della riabilitazione.......................................................................................143 6.3 Il percorso riabilitativo.........................................................................................143 6.4 L’offerta attuale del sistema extraospedaliero.......................................................145 6.5 Attività di lungodegenza......................................................................................157 6.5.1Definizioni.........................................................................................................157 6.5.2 Obiettivi............................................................................................................158 7. ASSISTENZA CONSULTORIALE.......................................................................160 Premessa...................................................................................................................160 7.1 Definizione, riferimenti normativi e ambiti di competenza...................................160 7.2 Attività consultoriali, percorsi e livelli assistenziali..............................................162 7.3 I percorsi di salute e la loro costruzione...............................................................164 7.4 Modello organizzativo.........................................................................................166 7.5 Settori per area disciplinare..................................................................................167 7.6 La programmazione.............................................................................................170 7.7 Il Monitoraggio delle attività................................................................................171 7.8 Requisiti minimi strutturali e tecnologici..............................................................173 7.9 Requisiti minimi organizzativi.............................................................................174 mercoledì 23 dicembre 2009 4 7.10 Requisiti e standard di fabbisogno indicativi......................................................174 7.11 Risorse economiche...........................................................................................175 7.12 Articolazione organizzativa................................................................................176 8 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE......................................181 8.1 Il contesto di riferimento: tendenze e sviluppi......................................................182 8.2 Le linee strategiche..............................................................................................183 8.3 Gli Obiettivi.........................................................................................................184 8.4 Le Azioni.............................................................................................................185 8.5 L’organizzazione dei servizi territoriali................................................................188 9. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.........................................................192 9.1 Salute mentale: quadro di riferimento..................................................................192 9.2 Mission del DSM.................................................................................................194 9.3 Ruolo della Regione.............................................................................................195 9.4 Struttura organizzativa.........................................................................................196 9.4.1 La direzione......................................................................................................197 9.4.2 Centro di Salute Mentale (CSM).......................................................................198 9.4.3 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)..............................................199 9.4.4 La psichiatria penitenziaria e l’OPG..................................................................200 9.4.5 Area ospedaliera di neuropsichiatria infantile di riferimento regionale - ospedale Madonna delle Grazie di Matera................................................................................201 9.4.6 Area di neuropsichiatria infantile servizi territoriali...........................................201 9.4.7 Area di assistenza di Psicologia Clinica.............................................................202 9.5 Area per la gestione di tutte le forme residenziali, semiresidenziali e riabilitative territoriali..................................................................................................................202 9.5.1 Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche..................................202 9.5.2 Il fabbisogno di posti letto.................................................................................207 9.6 Partecipazione......................................................................................................209 9.6.1 Accountability..................................................................................................209 10. RIDEFINIZIONE E RIORIENTAMENTO DEL SISTEMA DELL’OFFERTA. SVILUPPO DELLA RETE.........................................................................................214 10.1 Sussidiarietà verticale: il modello a rete delle specializzazioni e dei nodi inter- aziendali....................................................................................................................218 10.2 L’ospedale e il suo ambiente..............................................................................219 10.3 Il Modello “Hub & Spoke”................................................................................221 10.4 Rete della emergenza/urgenza............................................................................226 10.4.1 DIRES............................................................................................................226 10.4.2 Dipartimento dell’Emergenza/urgenza ed accettazione (DEA)........................227 10.4.3 Pronto soccorso attivo (PSA)..........................................................................228 10.4.4 Postazione Territoriali di Soccorso (PTS)........................................................228 10.4.5 Continuità assistenziale...................................................................................229 10.4.6 Mezzi di soccorso...........................................................................................229 10.4.7 La centrale operativa (CO)..............................................................................229 10.5 Rete cardiologica per l’Infarto Miocardico Acuto (IMA)....................................231 10.5.1 Modello assistenziale della rete......................................................................231 10.5.2 Obiettivi da raggiungere possono essere i seguenti:........................................233 10.6 Rete onco-ematologica.......................................................................................235 10.6.1 Modello assistenziale per il paziente onco-ematologico...................................236 10.6.2 I Centri di Accoglienza e Valutazione (CAV).................................................236 10.6.3 Struttura organizzativa oncologica..................................................................238 10.6.4 Struttura organizzativa delle rete ematologica.................................................238 mercoledì 23 dicembre 2009 5 10.6.5 La rete specialistica di 2° e 3° livello...............................................................239 10.6.6 Comitato Onco-ematologico Regionale...........................................................239 10.7 Rete dell’Ictus....................................................................................................240 10.7.1 Modello assistenziale della rete......................................................................240 10.7.2 Obiettivi per le Aziende..................................................................................242 11 METODOLOGIA PER LA STIMA DEL FABBISOGNO QUANTITATIVO DEI POSTI LETTO............................................................................................................244 11.1 Sintesi................................................................................................................244 11.2 Procedura di calcolo...........................................................................................245 11.3 Risultati.............................................................................................................250 11.4 Osservazioni......................................................................................................254 12. IL GOVERNO CLINICO.....................................................................................256 12.1 Organizzazione e modalità operative..................................................................258 12.2 Uno strumento del governo clinico: linee guida e percorsi assistenziali..............260 12.3 Uno strumento di verifica: l’Audit clinico..........................................................262 12.3.1 Metodi............................................................................................................263 12.3.2 Contenuti........................................................................................................263 12.4 Obiettivo............................................................................................................264 12.5 Azioni................................................................................................................264 13. I RISCHI DELLE CURE: UN TEMA DELICATO PER TUTTI.......................265 13.1 Conoscere, prevenire e gestire il Rischio clinico................................................267 13.2 L’analisi degli eventi dannosi.............................................................................268 13.3 Obiettivo............................................................................................................269 13.4 Azioni................................................................................................................270 13.5 Indicatori...........................................................................................................271 14. LA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE PER L’INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE..............................................................................................................272 14.1 L’HTA a livello regionale..................................................................................273 14.2 Azioni................................................................................................................274 14.3 Il modello organizzativo a livello regionale........................................................275 14.4 L’HTA a livello aziendale ed ospedaliero...........................................................276 14.5 Azioni................................................................................................................276 14.6 Il modello organizzativo a livello aziendale........................................................277 15. IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE CONTINUA..........................................278 15.1 Il contesto nazionale..........................................................................................281 15.2 Il modello di accreditamento regionale...............................................................282 15.2.1 Fasi operative..................................................................................................287 15.2.2 Planner operativo............................................................................................289 15.2.3 Comitato istituzionale tecnico scientifico per l’ECM regionale (CITSER).......290 15.2.4 Finanziamento del sistema ECM regionale......................................................291 15.2.4.5 Soggetti destinatari dell’obbligo dei crediti formativi ECM:.........................292 mercoledì 23 dicembre 2009 6 INTRODUZIONE Il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona (PRSS) redatto in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” ed nell’ambito del processo di riordino del Sistema sanitario regionale previsto dalla legge regionale 01 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”, è lo strumento di cui la Regione Basilicata si doterà per il governo e la gestione del sistema sanitario, socio- sanitario e della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale nel triennio 2010-2013. La redazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona è stata realizzata attraverso un ampio processo partecipativo che ha impegnato le varie componenti del sistema sanitario, le istituzioni locali e le espressioni organizzate della comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto si ritiene che solo da un processo partecipativo può nascere uno strumento interiorizzato nel contesto regionale e che avvii i necessari cambiamenti già nel periodo della sua predisposizione. Il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona è di tipo ordinatorio, ossia individua: (cid:1) gli obiettivi da perseguire; (cid:1) le caratteristiche che dovranno permeare le azioni di innovazione del sistema; (cid:1) i metodi e gli strumenti di regolamentazione dei soggetti erogatori; (cid:1) i macro standard dotazionali ed organizzativi entro cui le nuove Aziende Sanitarie, di cui all’articolo 2 della L.R. 12/2008, dovranno sviluppare la propria progettualità operativa; (cid:1) le metodologie e gli strumenti di valutazione degli esiti, della produzione e della qualità dell’offerta; (cid:1) la sperimentazione di settore come strumento di programmazione, prima della diffusione di modelli all’intero ambito regionale; (cid:1) le risorse da impiegare per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); mercoledì 23 dicembre 2009 7 (cid:1) gli obiettivi di affermazione e garanzia dei diritti di salute e di cittadinanza sociale emergenti dalla rilevazione sistematica delle esigenze e dei bisogni della comunità regionale; (cid:1) gli indirizzi operativi per perseguire la massima integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e con gli interventi formativi, educativi, culturali ed occupazionali; (cid:1) i macro standard dotazionali e qualitativi dei servizi e degli interventi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) nonché i criteri di efficacia e di efficienza da rispettare; (cid:1) i criteri e i principali standard di riferimento per le risorse professionali e le dotazioni finanziarie in relazione alla natura ed al volume delle attività da realizzare; (cid:1) gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti alla copertura del costo delle prestazioni sociali, nonché le condizioni per il rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali; (cid:1) gli obiettivi e le modalità attuative delle azioni regionali di promozione e di innovazione, ivi comprese quelle attinenti all’educazione e alla comunicazione sociale; (cid:1) i meccanismi di valutazione e di monitoraggio dell’attuazione del piano in relazione agli indicatori di esito e di benessere sociale adottati. Tale impianto potrà permettere: (cid:1) una valorizzazione delle progettualità aziendali e locali all’interno di strategie e regole certe; (cid:1) una non cristallizzazione di modelli organizzativi ed operativi che devono invece rimanere flessibili e prontamente adattabili alla continua evoluzione della domanda, dell’innovazione tecnologica e della operatività dei professionisti; (cid:1) una programmazione continua che si rende possibile a partire dalle sperimentazioni locali che potranno mettere a disposizione del sistema le pratiche che avranno garantito i migliori risultati evidenziati da un sistema di valutazione affidabile ed uniforme sul territorio regionale. (cid:1) la valorizzazione delle Professionalità sanitarie e sociali come leva per il cambiamento e l’innovazione. mercoledì 23 dicembre 2009 8 Il Piano della Regione Basilicata, dal titolo “Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona 2010-2013. Un Sistema di diritti e garanzie per la tutela della salute e del benessere della persona”, è articolato in due parti. La I Parte del documento integrato, più prettamente sanitaria, definisce i valori e gli obiettivi del sistema sanitario regionale, analizza il contesto socio-demografico ed epidemiologico del territorio lucano, individua le strategie per le singole aree del Sistema, declina le “logiche” e “le parole-chiave” che caratterizzeranno la politica sanitaria e sociosanitaria regionale nel prossimo futuro, definisce le risorse economiche per l’attuazione del Piano. La II Parte del Piano definisce le strategie, gli indirizzi e le modalità operative per la costruzione e l’attuazione della Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale. All’interno dei due documenti sono contenuti degli strumenti come “Lo Sportello unico di accesso ai servizi sociali e sanitari” e “L’Unità di Valutazione Integrata (UVI)” che si è preferito di riprendere in entrambe le parti del Piano. La logica di fondo è quella che viene tradotta, a forma di slogan, nel sottotitolo del PSSR: un sistema di garanzie per la salute e per l’integrazione sociosanitaria. Un sistema di garanzie significa rendere conto dei risultati e delle risorse utilizzate a tutti i portatori d’interesse del sistema assistenziale: ai cittadini e ai pazienti; alla comunità e le sue espressioni organizzate; agli operatori sanitari; ai privati erogatori di servizi sanitari, ai fornitori di beni, al mondo della comunicazione e informazione. Le parole-chiave che dovranno permeare le politiche del SSSR e dovranno trovare concreta applicazione nei processi attuativi del PSSR all’interno dei singoli contesti aziendali sono: (cid:1) sistema (cid:1) processi (cid:1) logiche di rete (cid:1) appropriatezza (cid:1) integrazione interdisciplinare e interprofessionale (cid:1) continuità assistenziale (cid:1) integrazione socio-sanitaria e intersettoriale (cid:1) sicurezza (cid:1) formazione Alla base degli indirizzi programmatori del Piano vi è un sistema di valori e principi forti e condivisi individuati a partire dall’art. 32 della Costituzione. mercoledì 23 dicembre 2009 9 (cid:1) Universalità, Unicità ed Equità. II sistema s’impegna a perseguire la parità di accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini proporzionalmente ai loro bisogni ed indipendentemente da luogo, età, genere e classe sociale di appartenenza. Il Sistema Sociosanitario Regionale è unico, organizzato in una rete di servizi strettamente collegati. Il finanziamento è pubblico; i cittadini contribuiscono in relazione alla loro capacità contributiva (sistema Solidale) ed hanno diritto alle prestazioni in base al loro bisogno. (cid:1) Tutela della salute. La salute è intesa come diritto da promuovere e tutelare. È , quindi, un diritto per il singolo cittadino e un dovere per la collettività. (cid:1) Soggettività e libertà. All’interno del sistema sanitario il valore della persona e i bisogni dei singoli e delle famiglie vanno difesi e valorizzati. Il diritto di scelta è pienamente tutelato e l’unico limite è rappresentato dai valori etici e dagli interessi generali della comunità regionale. (cid:1) Responsabilità collettiva. Alla comunità intera spetta la titolarità della tutela della salute attraverso il ruolo determinante della programmazione regionale e locale, nel rispetto della concorrenza tra pubblico e privato accreditato che può incrementare i livelli di efficienza e migliorare la qualità. (cid:1) Partecipazione. I cittadini sono protagonisti attivi delle decisioni in tema di salute. Per far sì che la loro partecipazione sia concreta è necessario promuovere lo sviluppo delle loro competenze per una scelta libera e consapevole dei comportamenti, dei servizi e delle cure. II Sistema Sanitario favorisce la partecipazione tramite l’adozione idonei processi di comunicazione con l’utenza ed un’adeguata informazione. (cid:1) Centralità del territorio, nelle sue diverse articolazioni sia in comunità che nelle strutture organizzative e gestionali, in una logica di molteplicità di soggetti “produttori di salute”. Risulta fondamentale valorizzare ed integrare anche i contributi della componente di volontariato e di associazionismo. (cid:1) Solidarietà, intesa non solo come partecipazione ai costi del sistema, ma come scelta di equa distribuzione di risorse sul territorio. (cid:1) Umanizzazione, come principio che sottende a tutte le attività, le azioni, le programmazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, affinché il “prendersi cura” delle persone e non della sola malattia, della disabilità o della fragilità, costituisca mercoledì 23 dicembre 2009 10
Description: