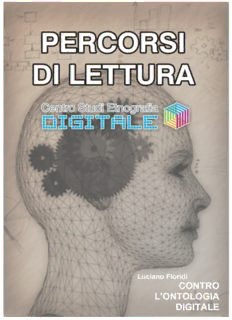
Luciano Floridi PDF
Preview Luciano Floridi
Luciano Floridi CONTRO L’ONTOLOGIA www.etnografiadigitale.it DIGITAL1 E Contro l’ontologia digitale Sommario L’articolo afferma che l’ontologia digitale (la natura ultima della realtà è digitale e l’universo è un sistema computazionale equivalente a una Turing Machine) dovrebbe essere attentamente distinta dall’ontologia informativa (la natura ultima della realtà è strutturale), al fine di abbandonare la prima e considerare solo la seconda come una linea di ricerca promettente. Digitale contro analogico è una dicotomia Booleana tipica del nostro paradigma computazionale ma digitale e analogico sono solo “modelli di presentazione” dell’Essere (per parafrasare Kant), cioè i modi in cui è sperimentata la realtà e / o concettualizzata da un agente epistemico a un determinato livello di astrazione. Un’alternativa preferibile è fornita da un approccio informativo al realismo strutturale, secondo il quale la conoscenza del mondo è conoscenza delle sue strutture. L’impegno ontologico più ragionevole è a favore di un’interpretazione della realtà intesa come totalità di strutture dinamicamente interagenti tra loro. L’articolo è la prima parte (la pars destruens) di una ricerca composta di due parti. La pars construens, intitolata “Una difesa del realismo strutturale informativo”, è disponibile in Synthese. Parole chiave Analogico; continuo; digitale; ontologia digitale; fisica digitale; discreto; realismo strutturale informativo; Antinomie di Kant; realismo strutturale. Quest’articolo è la traduzione dell’originale “Against Digital Ontology, Synthese” 2009, 168.1, (2009), 151-178 del Professor Luciano Floridi. La versione originale dell’articolo è direttamente scaricabile al link http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/ado. pdf. Luciano Floridi è Professore di Filosofia dell’Informazione presso la University of Hertfordshire. dove è anche titolare della cattedra UNESCO di Information and Computer Ethics. È membro del St. Cross College (Università di Oxford), dove dirige l’IEG (Oxford University Information Ethics research Group), di cui è anche fondatore. www.etnografiadigitale.it 2 1. Introduzione Negli anni recenti, l’antica questione circa l’evenienza che la natura della realtà sia discreta o continua1 È stata riformulata nei termini più alla moda di ontologia digitale e ontologia analogica. In tal modo, ha avuto una rinascita notevole. Comunque, come si vedrà a tempo debito, questo è un tipico caso di vecchio vino in bottiglie nuove. Ed io sosterrò che la conclusione di Kant, ottenuta in favore della vecchia e più classica dicotomia in “antinomie della ragion pura” (Kant [1998], A 434-5/B 462-3), non abbia perso alcuna validità se applicata alla più recente riformulazione della stessa scelta. L’articolo è strutturato in altre quattro sezioni principali. La sezione due fornisce una breve introduzione a ciò che è conosciuto come ontologia digitale. Nella terza sezione, la più lunga, viene introdotto un nuovo esperimento di pensiero al fine di mostrare come digitale (discreto) contro analogico (continuo) sia una dicotomia Booleana tipica del paradigma computazionale della nostra epoca, ma che sia digitale che analogico siano soltanto “modelli di presentazione dell’Essere” (per parafrasare Kant), cioè i modi in cui è sperimentata la realtà e / o concettualizzata da un agente epistemico a un determinato livello di astrazione (LoA). Non colgono alcune proprietà indipendenti – o livelli di astrazione - della conoscenza, intrinseche al mondo esteriore. Anche se questa conclusione si applica sia all’ontologia digitale che a quella analogica, l’articolo si concentra principalmente sulla critica dell’ontologia digitale (da qui il suo titolo) poiché il suo obiettivo positivo è quello di preparare il terreno per una difesa dell’ontologia informativa, che viene spesso confusa con l’ontologia digitale. La sezione quattro chiarisce ulteriormente l’argomento rispondendo a tra potenziali obiezioni. La sezione quattro, che conclude l’articolo, fornisce una nota positiva e una spiegazione delle motivazioni più costruttive per l'argomento sviluppato nelle sezioni precedenti. L’articolo è la prima parte ( la pars destruens) di una ricerca composta di due parti. La pars construens, intitolata “Una difesa del realismo strutturale informativo” è disponibile in Synthese. 1Holden (2004) fornisce un’analisi ricca e illuminante del moderno dibattito, cui devo molto. Mi sono basato anche sull’eccellente articolo di Lesne (2007). www.etnografiadigitale.it 3 2. Cos’è l’ontologia digitale? It from Bit Konrad Zuse2 è riconosciuto da molti come il padre dell’ontologia digitale3. Secondo lui e gli ontologisti digitali in genere: 1) la natura dell’universo fisico (tempo, spazio e ogni entità e processo nello spazio- tempo) è in ultima analisi discreta. Questa tesi, con la quale saremo impegnati per il resto dell’articolo, può essere accompagnata da (una selezione di) altre tre tesi correlate: 2) l’universo fisico può essere adeguatamente modellato da valori discreti come i numeri interi; 3) l’evoluzione (transizione di stato) dell’universo fisico è calcolabile come l'output di un (presumibilmente breve) algoritmo; e 4) le leggi che governano l’universo fisico sono interamente deterministiche. Le tesi (1) e (2) rivelano la natura neo-pitagorica dell’ontologia digitale (Steinhart [2003]): la realtà può essere scomposta in indivisibilia discreti e finali. I filosofi sono ancora in disaccordo sulla precisa definizione di “digitale” e “analogico”4, ma accettano che una necessaria caratteristica di ciò che significhi essere digitale per qualcosa è quella di essere discreta e ciò sarà sufficiente per i propositi dell’articolo. La tesi (3) interpreta l’ontologia neo-pitagorica in termini computazionali: i definitivi, discreti indivisibilia sono cifre realmente computabili, mentre l’eleganza e il rasoio di Ockham inducono gli ontologisti digitali a propendere per una teoria algoritmica più semplice possibile (vedi Feynman [1992], citato sotto nel § 3.3.2). Così, un’ontologia digitale “[…] è basata su due concetti: i bit, come le cifre binarie in un computer, corrispondono alla più microscopica rappresentazione dello stato dell’informazione; e l’evoluzione temporale dello stato è un processo digitale informativo simile a ciò che accade nel circuito di un processore per computer.” (Fredkin [2003], 188). In poche parole, “siamo gestiti da un breve algoritmo” (Schmidhuber [1997], p. 205). 2 Zuse è famoso per aver costruito il primo calcolatore binario elettromeccanico totalmente programmabile e totalmente automatico (lo Z3), vedi Zuse [1993]. 3 L’ontologia digitale è conosciuta anche come fisica digitale o metafisica digitale e filosofia digitale e ha una controparte scientifica nella fisica digitale, vedi Steinhart (1998) per un’introduzione e Steinhart (2003) per un capitolo di revisione. Per una bibliografia recente vedi http://digitalphysics.org/Publications/. 4 Il dibattito tra Goodman (i968) e Lewis (1971) sulla vera natura del “digitale” è stato recentemente rivisitato da Müller (prossimamente). Sulla non necessaria distinzione tra sistemi discreti e discretizzati vedi Lesne (2007): “Ora sembra che non ci siano ragioni per fare una distinzione fondamentale tra sistemi discreti e discretizzati: un oggetto sembra essere intrinsecamente discreto, isolato inoltre, solo se si scelgono gli occhiali opportuni.” (p.14) Gli “occhiali” sono interpretati più formalmente in questo articolo in termini di livelli di astrazione. www.etnografiadigitale.it 4 Come per la tesi (4), ciò è presentato dai sostenitori dell’ontologia digitale5 come una conseguenza diretta delle tesi (1) e (3) alle quali è esplicitamente correlata dalla riluttanza di Einstein ad accettare la conclusione che l’universo possa essere intrinsecamente probabilistico. La suggestione è che l’analisi delle leggi fisiche in termini di transizioni deterministiche di stato possa essere resa compatibile con la natura apparentemente probabilistica dei quantum phenomena, pur essendo sufficientemente flessibile da superare altre critiche6. La posizione che unisce la maggior parte dei sostenitori dell’ontologia digitale è riassunta in ciò che è noto come tesi di Zuse: ZT) “l’universo è in fase di calcolo deterministico su una sorta di enorme ma discreto computer” (Zuse [1969]). Il computer cui ci si riferisce nella tesi di Zuse potrebbe essere un automa cellulare. Ciò è sostenuto da Zuse (1967), anche sulla base di Von Neumann (1966), da Fredkin (2003b) e, più recentemente, da Wolfram (2002)7. Infatti, una variante meno generale della teoria di Zuse è conosciuta come teoria di Fredkin-Zuse: “L’universo è un automa cellulare” (Petrov [2003]). Alternativamente, il computer nella teoria di Zuse potrebbe essere una Turing Machine universale, come suggerito da Schmidhube; o un quantum computer, come proposto più recentemente da Lloyd (2006). Altri ben noti proponenti di versioni della tesi di Zuse sono David Chalmers [1996], il premio Nobel Gerard 'T Hooft [1997], e Gregory Chaitin [2005]. L’ultimo ha esplicitamente interpretato l’ontologia digitale come uno sviluppo contemporaneo della metafisica dei Pitagorici, dell’atomismo di Democrito e della monadologia di Leibniz. Inoltre, nella Critica della 5 Fredkin (1992) presenta il punto con la solita chiarezza: “L’incertezza è il cuore della meccanica quantistica. La natura finita richiede che si escluda il vero, localmente generato in maniera casuale poiché tali numeri non sarebbero, in questa situazione, considerati finiti. …] La natura deterministica di processi digitali finiti è differente i quello che è il determinismo inconoscibile. Da dentro il sistema, un osservatore non sarà mai in grado di conoscere molto circa il microscopico stato di quel sistema. Ogni parte dello spazio sta calcolando il suo futuro il più velocemente possibile, mentre l’informazione si riversa in ogni direzione possibile. Il risultato è lo stesso che è causata dall’apparente casualità dei processi di meccanica quantistica.”. Vedi anche 'T Hooft [2002] e 'T Hooft [2005]. 6 Per esempio, l’ontologia digitale sembra incompatibile con il teorema di Bell, ma una soluzione per bypassare il problema, conosciuta come pre-determinismo ('T Hooft [2005]), è basata su quello che lo stesso Bell riconosceva come una possibilità: se un modello è completamente deterministico, allora anche la decisione dello sperimentatore di misurare alcuni componenti degli spin è completamente deterministica, così non può aver deciso di misurare nient’altro che ciò che aveva deciso di misurare. 7 Per essere precisi, è stato sostenuto che non è chiaro se Wolfram intenda supportare la visione per la quale l’universo è un automa cellulare classico. Wolfram riconosce i lavori di Zuse e Fredkin nelle pp. 1026-1027, ma solo molto brevemente e sostiene che “nessun modello meccanicistico letterale può mai alla fine realisticamente funzionare”. Io seguo l’interpretazione di Edwin Clark nel leggere questa come un rifiuto dell’automa cellulare classico. Wolfram sembra avere in mente qualcosa di leggermente diverso: “[…] ciò che deve accadere dipende dai fenomeni scoperti in questo libro – e include la comparsa di complesse proprietà […]”. Le potenziali differenze tra Fredkin e Wolfram su questo argomento, comunque, non sono significative per la discussione sulla plausibilità dell’ontologia digitale. www.etnografiadigitale.it 5 ragion pura, Kant chiamava Monadologista qualunque filosofo detenesse un’ontologia “discreta”. La prospettiva globale, emergente dall’ontologia digitale, è parte di un monismo metafisico: in ultima analisi, l’universo fisico è un gigantesco computer digitale. È fondamentalmente composto di cifre, invece che da materia o energia, con oggetti materiali come manifestazione complessa secondaria, mentre i processi dinamici sono delle specie di transizioni computazionali di stato. Non ci sono infiniti, infinitesimi, continuità o variabili determinate localmente e casualmente irriducibili digitalmente. In breve, la natura ultima della realtà non è liscia e casuale ma ruvida e deterministica8. Giacché nel resto del presente articolo mi concentrerò solo sulla questione della natura digitale o analogica della realtà, cioè la tesi (1) presente all’inizio di questa sessione, lasciatemi terminare questa breve presentazione dell’ontologia digitale con un commento finale circa la natura computazionale dell’universo fisico. Si tratta di una distinzione importante che è bene mettere in evidenza e sulla quale tornerò brevemente nelle conclusioni. Abbiamo visto che come gli ontologisti digitali tendano ad avere una mentalità computazionale e sottoscrivono quindi alcune versioni della tesi pan computazionale, secondo le quali l’universo fisico è un sistema computazionale di qualche tipo, dove il tipo è irrilevante fintanto che i modelli computazionali preferiti sono equivalenti, come Turing Machine, automi cellulari, quantum computer o addirittura le reti neurali ricorrenti9. Ad ogni modo, l’ontologia digitale e il pancomputazionalismo sono posizioni indipendenti. Notoriamente, Wheeler supportò la prima ma non (per lo meno non esplicitamente) la seconda. Come scrive lui stesso: It from bit. Ovvero, ciascun “it” – ogni particella, ogni campo di forza, anche il continuum spazio tempo stesso - deriva la sua funzione, il suo significato, la sua stessa esistenza interamente – anche se indirettamente in alcuni contesti – dalle risposte generate dall’apparato a domande si-o-no, scelte binarie, bit. “It from bit” simboleggia l’idea che ogni 8“ Una questione fondamentale riguardante il tempo, lo spazio e i loro abitanti è “Le cose sono lisce o ruvide?” Talune cose sono ovviamente ruvide (materia, carica, momento angolare); per altre cose (spazio, tempo, momento, energia) le risposte non sono chiare. La Natura Finita è l’assunzione che, a un certo livello, spazio e tempo sono discreti e che il numero di stati possibili di ogni volume finito di spazio-tempo è finito. In altre parole la Natura Finita assume che non c’è cosa che sia liscia o continua e che non esistono infinitesimali.” Fredkin (1992). 9 Non conosco nessuno che supporti tale posizione, forse perché le reti neurali artificiali solitamente non sono analizzate algoritmicamente, ma è disponibile nella misura in cui qualunque funzione calcolabile algebricamente possa essere espressa come una rete neurale ricorrente, vedi Hyötyniemi [1996] e Siegelmann [1998]. www.etnografiadigitale.it 6 oggetto del mondo fisico abbia alla base – una base molto profonda, in molti casi – una fonte immateriale e una spiegazione; quella che noi chiamiamo realtà nasce in ultima analisi, dal porre domande si-no e dalla registrazione di risposte evocate dall’apparecchiatura. In breve, che tutte le cose fisiche sono in principio informazioni teoriche e che questo è un universo partecipativo (Wheeler [1990],5). I processi fisici nell’universo partecipativo di Wheeler potrebbero, ma non lo necessitano, essere riducibili a transizioni computazionali di stato. D’altra parte, pancomputazionalisti come Lloyd (2006), il quale descrive l’universo con come una Turing Machine ma come un quantum computer, possono possedere ancora un’ontologia analogica o ibrida10. Il demonio di Laplace, per esempio, è un pancomputazionalista analogico. E ontologisti informazionali come Sayre (1976), o io stesso (Floridi [2004] e Floridi [prossimamente]) non devono abbracciare un’ontologia digitale o una posizione pancomputazionalista come descritto nella Tesi di Zuse. La distinzione tra ontologia digitale, ontologia informazionale e pancomputazionalismo è cruciale per comprendere la strategia di questo articolo, che consiste nel criticare l’ontologia digitale al fine di fare spazio a un approccio informazionale al realismo strutturale, difeso in Floridi (prossimamente), pur non impegnandosi nel pancomputazionalismo. Tornerò su questo punto nelle conclusioni. Con questa chiarificazione in mente, possiamo ora passare alle obiezioni contro l’ontologia digitale. 2.1 Ontologia digitale: da problemi fisici a problemi metafisici. Discutendo sull’ontologia digitale, sorgono due questioni separate: a) se l’universo fisico possa essere modellato digitalmente e computazionalmente, indipendentemente dal fatto che se sia realmente digitale e computazionale in se stesso; e b) se la natura ultima dell’universo fisico possa essere realmente digitale e computazionale in se stesso, indipendentemente da come possa essere effettivamente o adeguatamente modellato. La prima è una questione empirico-matematica che, fino a ora, rimane incerta. Dirò un po’ di più a riguardo in questa sezione, ma il resto dell’articolo non si interessa ad essa. La 10 I computer ibridi posseggono caratteristiche dei comupter analogici e dei computer digitali. La componente digitale normalmente serve come controller e fornisce operazioni logiche; la componente analogica normalmente serve come risolutore di equazioni differenziali. Esonero da responsabilità di plagio: la definizione precedente è la fonte della definizione corrispondente a Wikipedia, non viceversa. www.etnografiadigitale.it 7 seconda è una questione metafisica che, nel resto dell’articolo, spero di dimostrare di come sia mal posta e quindi, una volta risposto, che sia disapplicata. Le risposte ad (a) e (b) sono spesso intrecciate. Il passaggio seguente di Edward Fredkin, uno dei più zelanti sostenitori dell’ontologia digitale, fornisce un buon esempio di una sintesi unificata: [l’ontologia digitale] è un sistema totalmente atomistico. È presumibile che tutto il fondamentale sia atomico o discreto; e, quindi, così è tutto il resto. In fisica la filosofia digitale (che in questo articolo è stata chiamata ontologia digitale) assume che lo spazio e il tempo siano discreti. Ci sono due modelli matematici di tale sistema. Il primo è l’analisi diofantea; la matematica degli interi. Il secondo è la teoria degli automi; la matematica dei processi digitali. Scegliamo la seconda poiché ha anche la proprietà di rappresentare esplicitamente processi temporali discreti, mentre la matematica degli interi stabilisce semplicemente un insieme di teoremi, rappresentando implicitamente solo processi temporali. Tremendi progressi nelle scienze hanno seguito la scoperta del calcolo (e delle equazioni differenziali parziali) come modo per rappresentare matematicamente le relazioni fisico-temporali. Ma focalizziamoci altrove rispetto ai modelli fondamentali di processi fisici. Ciò che dobbiamo domandare della filosofia digitale è l’eventuale abilità di derivare, dai nostri modelli dei processi fondamentali di filosofia digitale, le stesse equazioni matematiche che costituiscono la base della scienza attualmente. Il Game of Life di Conway (un famoso automa cellulare) È un buon esempio di un semplice sistema digitale e delle conseguenti proprietà emergenti. Assumiamo arbitrariamente che la filosofia digitale rappresenti lo stato dagli schemi di bit, come avviene nei computer ordinari. Tutte le trasformazioni fondamentali che possiamo compiere con i bit in un computer sono realmente un sottoinsieme di quello che i matematici possono fare con gli interi. […] I bit della meccanica digitale esistono in punti in uno spazio tempo digitale regolare, dove ogni punto contiene un bit di informazione. Pensiamo lo spaziotempo come digitale dal momento che è fatto di soli punti collocati, in cui tutte le coordinate sono numeri interi. La teoria degli automi e la scienza dei computer ci portano a credere che la rappresentazione dello stato tramite bit non impone alcuna limitazione al di là del fatto che ogni cosa è in ultima analisi quantizzata. I computer e i relativi software sono le cose più complesse mai fatte dall’uomo. In ogni caso, la computazione è basata sul più semplice principio mai scoperto. Il nostro mondo è complesso e siamo alla ricerca di modelli www.etnografiadigitale.it 8 semplici che possano starvi alla base. I principi della filosofia digitale ci richiedono di trovare e iniziare con i più semplici modelli possibili. Dunque l’unità dello stato è il bit, che è considerevolmente più semplice di un numero reale. (Fredkin [2003 b], 190-191). Come illustra il passaggio, la posizione empirico-matematica e quella metafisica riguardo all’ontologia digitale sono compatibili e complementari. Si consideri il seguente modo di interpretare l’ontologia digitale. Simulazioni o modelli fisici possono condividere la stessa ontologia con i loro sistemi o modelli simulati. Così, un tunnel del vento, usato per investigare gli effetti della velocità del vento e il flusso attorno oggetti solidi, è davvero ventoso, più o meno spazioso, può contenere diversi oggetti fisici e così via. Comunque, le simulazioni digitali (al computer) o i modelli hanno spesso un’ontologia diversa da quella dei loro rispettivi sistemi. Una simulazione di fluidodinamica computazionale, usata per modellare e simulare il comportamento di flussi d’aria, non è né ventosa né bagnata di per sé. In ogni caso, enfatizzo “often” perché non è sempre questo il caso. Ad esempio, le simulazioni al computer sono usate abitualmente per testare e mettere a punto altri programmi applicativi, nel qual caso simulatore e simulato condividono la stessa ontologia digitale. L’ontologia digitale può anche essere interpretata sostenendo che uno possa avere un modello digitale o una simulazione della natura ultima dell’universo fisico che finisce condividendo la stessa ontologia digitale con il sistema modellato. Anche se una domanda a (a) potrebbe poi spianare la strada a una risposta a (b), è utile tenere le due questioni separate poiché affrontano sfide diverse. La posizione empirico-matematica cerca di rispondere alla questione (a) ed è più debole, e dunque meno difendibile, della posizione metafisica, che cerca di rispondere alla questione (b), perché potrebbe evitare ogni impegno ontologico verso la natura ultima della realtà. Il fatto che il sistema possa essere modellato e simulato digitalmente, ad esempio come un automa cellulare, non implica che la natura intrinseca di tale sistema sia digitale. Questa mancanza di impegno ontologico potrebbe essere un vantaggio e, occasionalmente, la posizione più debole sembra essere tutto ciò che gli ontologisti digitali desiderino mantenere. Toffoli [2003], per esempio, che simpatizza per l’ontologia digitale, ha proposto di trattarla come una linea di ricerca euristicamente rilevante: Sosteniamo che un aspetto non frivolo di questa Prospettiva Digitale è la sua capacità euristica: di aiutarci nell’indovinare quali aspetti della nostra comprensione della natura www.etnografiadigitale.it 9 siano più “universali”, più robusti, con più possibilità di sopravvivere a sfide teoriche e sperimentali. Comportamenti indipendenti dal substrato – che possano, per esempio, crescere bene su un supporto digitale, anche se tradizionalmente immaginati come facenti parte di un continuum – sono candidati particolarmente promettenti. (p.147) E Fredkin [online] stesso suggerisce che Ci sono sistemi computer (automi cellulari) che possono essere appropriati come modelli per fenomeni fisici microscopici. Gli automi cellulari sono in procinto di essere usati per modellare vari fenomeni fisici normalmente modellati da equazioni delle onde, fluidodinamica, modelli di Sino, etc. Noi ipotizziamo che verrà scoperta una regola dell’ automa cellulare singolo che modelli tutta la fisica microscopica; e che la modelli esattamente. Chiamiamo questo campo DM, che sta per meccanica digitale. Entrambi i passaggi potrebbero facilmente esser letti come rispondenti alla sola questione (a). Se l’ontologia digitale è una risposta ad (a) e non (anche) a (b), allora, anche se le obiezioni contro il valore metafisico dell’ontologia digitale potrebbero essere corrette, nulla può essere dedotto da loro con riguardo alla tenuta scientifica della fisica digitale interpretata debolmente. Forse qualcuno potrebbe voler sostenere che la seconda sarebbe danneggiata da una mancanza di un supporto ontologico ma, personalmente, io dubito che ciò abbia grandi conseguenze sulla fisica digitale. Dunque supponiamo che gli ontologisti digitali preferirebbero supportare la loro posizione come una risposta ad (a) e non a (b), al fine di evitare complicazioni metafisiche. Anche la posizione debole non è esente da problemi. In termini di ontologia empirica, la maggior parte dei fisici ignora o è positivamente scettico circa il valore dell’approccio. Nelle parole di un sostenitore dell’ontologia digitale: Molti di quelli che sono intervenuti in questo meeting [il workshop “The Digital Perspective”, organizzato da Edward Fredkin] esprimono il loro ottimismo riguardo alla possibilità di descrivere modelli realistici dell’Universo in termini di scenari deterministici “digitali”. La maggior parte dei fisici, comunque, sono profondamente consapevoli degli www.etnografiadigitale.it 10
Description: