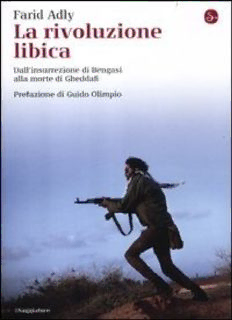
La rivoluzione libica. Dall'insurrezione di Bengasi alla morte di Gheddafi PDF
Preview La rivoluzione libica. Dall'insurrezione di Bengasi alla morte di Gheddafi
Farid Adly LA RIVOLUZIONE LIBICA Dall’insurrezione di Bengasi alla morte di Gheddafi Prefazione di Guido Olimpio © il Saggiatore S.p.A., Milano 2012 Presentazione Otto mesi d’insurrezione, repressione, guerra di liberazione e intervento internazionale. Cinquantamila morti, duecentomila feriti, centinaia di migliaia di sfollati e rifugiati. Fino all’esecuzione sommaria del colonnello Gheddafi, per quarantadue anni dittatore della Libia, che aveva minacciato di sterminare gli abitanti di Bengasi pur di mantenere la presa sul potere. L’inaspettata rivoluzione libica, iniziata il 17 febbraio 2011, pone diversi interrogativi sul futuro di un’intera nazione. Com’è scattata l’insurrezione a partire dalle manifestazioni di protesta spontanee sull’onda del successo dei movimenti rivoluzionari di Tunisia ed Egitto? Si può parlare d’intervento militare umanitario? Quale validità ha la tesi della cosiddetta «eccezione araba» sull’inconciliabilità fra Islam e democrazia? E la Libia, legata all’Italia da un’infelice storia coloniale, riuscirà a garantire al proprio popolo democrazia, stabilità politica ed equa distribuzione della ricchezza petrolifera? Farid Adly dà un volto agli eventi fatidici e agli scontri armati che hanno portato alla caduta del regime e riflette sugli interrogativi posti dalla rivoluzione libica, analizzando anche il ruolo e il coinvolgimento delle potenze straniere negli affari della famiglia Gheddafi . La sua voce autorevole conduce il lettore sul sentiero della conoscenza dei fatti e della loro genuina interpretazione, partendo dal suo essere un osservatore di provata professionalità e al contempo protagonista emotivamente coinvolto, «con le braci in mano», nel processo di cambiamento democratico del suo paese. Farid Adly è un giornalista libico che da anni risiede in Italia. Collabora con Radio Popolare, il Corriere della Sera e il Manifesto. Negli anni settanta ha fondato a Milano un periodico dedicato al Medio Oriente, Al-Sharara (La Scintilla). In ricordo del professor Guido Valabrega, maestro che ha illuminato il cammino della mia ricerca storica e sociale, e amico affettuoso che non si è mai risparmiato nel confortarmi nei momenti difficili, a causa delle note vicende e tragedie del Vicino Oriente. Prefazione di Guido Olimpio Popolazioni che si ribellano dalla Libia alla Siria. Movimenti popolari. Rivolte armate. Dittatori inamovibili strappati a forza dai loro troni. Vecchi sistemi di potere e relazioni stravolti. Un vulcano politico e sociale che non si è ancora spento. Una realtà non sempre facile da decifrare. Tanto per i diplomatici che per i giornalisti, costretti a inseguire processi repentini. Spesso brutali, con conseguenze tutte da decifrare. Sappiamo, forse, come sono iniziate molte di queste storie ma non possiamo dire come finiranno. Per questo è prezioso e vitale, quando si deve seguire crisi di queste proporzioni, avere un punto di riferimento. Una figura che racchiude molti ruoli: giornalista, analista, esperto, figlio di quella terra inquieta che è il Nord Africa. Con la non comune caratteristica di essere libico trapiantato da decenni in Italia. Farid Adly è tutto questo. Per me – e per il Corriere della Sera – Adly, oltre che essere un amico, è diventato una fonte preziosa. Che ti informa ma è pronta ad ascoltare. In uno scambio di idee che porta poi a risultati concreti, ti evita di scrivere imprecisioni, ti permette di avere quei particolari che possono fare la differenza e attirare l’occhio dei lettori più critici. In questi anni di collaborazione, continua e precisa, abbiamo discusso di tutto. Con passione, con senso critico e ricerca dei fatti. Un percorso giornalistico iniziato con la tragica pagina dell’11 settembre 2001 e che non si è mai interrotto. Farid Adly mi ha aiutato a interpretare articoli, a cogliere quelle sfumature così importanti della lingua araba, a scoprire notizie nei lunghi interventi di capi estremisti e leader. La sua telefonata o l’email sono spesso arrivate prima del dispaccio di agenzia o della notizia lampo lanciata dalle tv. Un’allerta accompagnata dall’inconfondibile: «Controllo e ti dico». A volte il processo è scattato in senso inverso: «Guarda ho letto che…Vedi se c’è qualcosa in giro». Una richiesta d’aiuto mai caduta nel vuoto. Una risposta mai banale. Perché insieme alle news nude e crude – quelle che ogni reporter insegue – c’era e c’è un’annotazione. Un’idea su cui lavorare. Ma non un’imposizione. Ed è questo il bello di lavorare con Farid. Niente dogmi, nulla di scontato, grande prudenza nel decifrare gli eventi. A volte abbiamo messo insieme i pezzi dopo giorni di ricerca paziente. Io da una parte e lui dall’altra. E il nostro asse professionale è cresciuto – inevitabilmente – con l’insurrezione in Libia, la terra natale del collega. Il paese dal quale per anni è stato costretto a rimanere alla larga. Quando si sono accesi i primi lampi di rivolta abbiamo avviato un meccanismo che ricordava un’altra epoca del giornalismo. Quando non c’erano telefonini e computer. Allora c’era la «fissa», un appuntamento telefonico o al telex con l’inviato. Era il solo modo per comunicare. Ebbene, per mesi, ci siamo sentiti con due chiamate quotidiane. Io a Washington, lui in Italia. La prima nel mattino americano, per capire cosa era accaduto durante la notte e verificare le news apparse sui media. La seconda consultazione era quando in Italia si dormiva, per fare un bilancio. Tra questi due appuntamenti un mare di contatti, di email, di messaggi. Inseguendo quelle straordinarie e drammatiche giornate che hanno cambiato il volto della Libia. Sono nati così «pezzi» a quattro mani sullo status del regime, sugli sviluppi militari, sulle divisioni dei clan, su prospettive e pericoli. Ma con un approccio «laico». Farid Adly ha difeso le scelte dei suoi connazionali ma non ha mai avuto paura di rimarcare errori e iniziative pericolose. Un approccio giornalistico riconosciuto anche da tanti colleghi e osservatori. Appassionanti le ricerche – e le discussioni – su cosa avrebbe fatto Gheddafi, su cosa si agitava nella mente di un leader indecifrabile, se alla fine si sarebbe arreso. E poi i «lavori» sul denaro all’estero, sugli aiuti di altri paesi, sul flusso di mercenari. Non c’è aspetto che non sia stato affrontato e sviscerato. A volte per realizzare un articolo, altre solo per il gusto di archiviare dati importanti ed essere pronti al momento opportuno. Con l’autore di questo libro non condivido solo la passione per il mondo arabo ma anche il metodo di lavoro. Che è sì giornalistico ma reso più profondo da un sistema – come si dice in gergo – di «scavo». Un metodo fatto di passi costanti: raccolta, archiviazione, analisi, verifiche. Ma con la voglia di essere un passo avanti nel mettere insieme i famosi tasselli del mosaico. Se poi non si tramuterà in un «pezzo» – ce lo siamo detti tante volte – non importa. Certi che prima o poi vi sarebbe stata un’occasione. E così è stato. A Farid Adly va poi riconosciuta l’obiettività. In questi mesi non ha mai smesso di mettere in guardia sull’ambiguità di alcune forze all’interno al movimento ribelle, sulle possibili infiltrazioni qaediste, sulle manovre poco chiare e sui tanti Gattopardi, abili nel cambiare pelle una volta che il tiranno è caduto. Una denuncia proseguita con le denunce degli eccessi e delle violenze compiute dalle milizie libiche nei confronti di migliaia di civili. Aver cacciato un despota non autorizza nessuno a ritorsioni e persecuzioni. E se ogni rivoluzione si porta dietro regolamenti di conti – purtroppo inevitabili – bisogna adoperarsi perché cessino il più presto possibile. E questo libro – La rivoluzione libica – è la ricostruzione rigorosa di mesi tumultuosi e pieni di incognite. Una catena di eventi dove il primo anello non è l’insurrezione popolare di Bengasi del 2011 ma qualcosa accaduto molto tempo prima: la strage nel carcere di Abu Selim nel 1996. Da qui si sviluppa un viaggio drammatico, appassionante e sconvolgente che si chiude con il crollo di un despota che sembrava imbattibile. Un finto matto capace di sopravvivere tra gli intrighi del Medio Oriente, furbo come pochi nel giocare su mille tavoli, spregiudicato nel dire una cosa e farne un’altra. Un leader che si atteggiava a padre dei libici e poi mandava i suoi agenti a eliminare gli oppositori all’estero. Predicava la pace e poi organizzava legioni straniere per combattere i rivali in Africa. Faceva affari con tutti e trescava con organizzazioni terroristiche, armandole e finanziandole. Episodi narrati con precisione dall’autore, in un racconto tra cronaca e storia. Nel libro si illuminano aspetti poco esplorati. Come il ruolo delle donne nella società libica, l’esistenza di realtà economiche difficili che sfatano la leggenda che in Libia sono «tutti ricchi», lo sfruttamento degli immigrati venuti dal cuore dell’Africa. E non mancano spunti polemici per chi in Occidente sembrava rimpiangere i bei tempi di Gheddafi, pronto a fare a pezzi i capi della rivolta. Non meno «calde» le riflessioni sui tanti amici del colonnello che aveva estimatori interessati nel nostro paese. Farid Adly affronta anche il tema dello scontro laici-religiosi, una costante delle rivoluzioni arabe, così come le difficili scelte per chi ha appena iniziato a gestire un sistema democratico. Con errori prevedibili e accettabili. Ma anche con comportamenti da rinnegare, come le vendette nei confronti di chi non ha abbracciato la nuova rivoluzione. L’autore non ignora questo lato oscuro, lo racconta, lo sanziona. Ma, a dispetto di scenari foschi e apocalittici, ha fiducia nelle capacità di un popolo che si è lasciato alle spalle decenni di terrore. Il libro si chiude con un sentito messaggio: «Auguri terra mia». Auguri che facciamo nostri e rilanciamo, sperando che la Libia trovi la sua strada sicura. Guido Olimpio Washington, 25 febbraio 2012 La genesi di una rivoluzione: la strage nel carcere Abu Selim La prima volta che ho appreso «ufficialmente», ma indirettamente, della strage di detenuti nel carcere Abu Selim, un sobborgo a sudovest della capitale libica, è stato nella stessa sede centrale di Tripoli del Mukhabarat, il servizio segreto di sicurezza del regime. Ero andato per seguire la pratica del mio passaporto sequestrato alla frontiera libico-tunisina di Abu Jdeir, al momento del mio rientro nel dicembre 1996. Allora la Libia era sotto embargo Onu per l’attentato di Lockerbie e non c’erano voli diretti da e per il paese. Colonnello Mustafa. Così si è presentato, senza cognome, il personaggio che doveva delucidarmi sulle ragioni del sequestro del passaporto da parte della polizia. Dopo i soliti salamelecchi che si scambiano i libici ogni volta che si vedono, si è chiuso in un eloquente mutismo. Il viso contornato dai palmi delle due mani con i gomiti appoggiati sul tavolo, guardava assorto in un punto indeterminato dell’ampia stanza, senza profferire parola. Conoscendo l’ambiente, anch’io ho ricambiato con la stessa moneta. Dopo un interminabile, per me, lasso di tempo con uno scatto ha schiacciato un pulsante e nella stanza adiacente si sono sentiti il suono di un campanello, il rumore di una sedia e i passi di un uomo dagli scarponi militari. L’ufficiale entrato aveva tra le mani un dossier. Dalla confabulazione fra i due, pur in arabo, sembrava che usassero un codice per comunicare. Quando il mio fascicolo è stato posato sul tavolo del colonnello, l’ufficiale ha pronunciato le uniche parole a me comprensibili: «Non merita un trattamento alla Abu Selim!». L’accostamento non mi era molto chiaro. Della durezza del carcere speciale di Abu Selim, in Libia, tutti raccontavano aneddoti e storie al limite dell’impossibile. Ma le voci che giravano dalla precedente estate erano, a dir poco, allarmanti. Circolavano notizie, trasmesse dal tam tam popolare, su una rivolta dei detenuti politici repressa nel sangue, con molti morti. Uccisi nelle celle, si diceva. Non si scendeva nei particolari, non si facevano nomi. La radio e la tv di Stato non ne hanno mai parlato e la stampa scritta, tutta in mano al ministero dell’Informazione, men che meno. «Si mette male» ho pensato. In questi casi, la cosa migliore è quella di mantenere la calma e di non reagire alle provocazioni; si tradirebbe altrimenti uno stato d’animo debole. Ho continuato a fissare il dossier, poi, incrociando gli occhi del mio interlocutore, ho chiesto lumi sulla sorte del mio documento. Dopo aver consultato le carte, il colonnello ha iniziato un lungo ragionamento, prendendola da lontano. Un discorso sul potere, sull’affidabilità delle persone, sulla patria e sulla nostalgia, sulle forme pratiche della sovranità popolare, sul socialismo che non vuol dire povertà, ma neanche uguaglianza, sul privilegio di chi ha studiato e sulla riconoscenza che è sottomissione al potere del popolo. «Chi gode della fresca aria d’Europa, non dovrebbe dimenticare la calura dei nostri deserti» ha concluso in modo sibillino. Frasi scollegate che non formavano un discorso compiuto e non seguivano un ragionamento logico con premesse e conclusioni. Soprattutto non avevano nulla a che fare con la storia che vedeva il mio passaporto sequestrato come protagonista principale, e la cui eventuale mancata soluzione metteva in serio pericolo tutto il programma del mio breve soggiorno in Libia e il sicuro rinvio del viaggio di ritorno in Italia. Con tutto il self control del quale sono dotato ho indicato il fascicolo e ho chiesto esplicitamente se quel giorno stesso sarei potuto tornare a Bengasi con il mio documento. La risposta è stata lapidaria: «La pratica è lunga. Manca la firma». Non c’era da scherzare; la percezione che ho avuto era quella di una richiesta di collaborazione. «Torni tra una quindicina di giorni.» Seduta tolta. Il calvario durò tre lunghi mesi. I monologhi del colonnello si erano trasformati in discussioni. Non avevo nulla da perdere, avendo perso la speranza di vedere riconsegnato il mio documento di viaggio. Sapevano tutto sulla mia vita in Italia. Dalla direzione del movimento degli studenti libici alla solidarietà con i palestinesi, dall’occupazione dell’Ambasciata libica di Roma ai tempi dell’impiccagione degli studenti all’Università di Bengasi, nel 1977, alle manifestazioni contro la guerra nel Golfo, dall’andamento degli studi al lavoro a Radio Popolare, e soprattutto sapevano della trasmissione Radio Shaabi, in lingua araba. Non mancavano riferimenti alle frequentazioni di amici e fidanzate, con trascrizione dei loro nomi, in arabo, un po’ storpiati. Mi rendevo conto che parlando e discutendo non avrei aggiunto nulla alle loro conoscenze. Il gioco era ormai a carte scoperte, esplicito. Ho ripetutamente declinato ogni offerta, ma il mio interlocutore non desisteva. Elogi lusinghieri, «il paese ha bisogno dei suoi figli migliori», si alternavano con cupe prospettive, «perdere il comodo lavoro di giornalista, per di più in una bella città come Milano, sarebbe un vero peccato!». La confidenza era diventata tale, che i nostri dialoghi avevano assunto una dimensione culturale, non aspettata in un poliziotto, scoprendo passioni comuni per la poesia di Mahmoud Darwish e per il romanzo di Abdel- Rahman Munif Città di sale.
