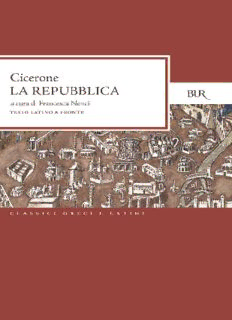
La Repubblica PDF
Preview La Repubblica
Marco Tullio Cicerone LA REPUBBLICA Introduzione,traduzione e note di Francesca Nenci Testo latino a fronte CLASSICI GRECI E LATINI Proprietà letteraria riservata © 2008 RCS Libri S.p.A.,Milano ISBN 97888-58-64897-1 Titolo originale dell’opera: De re publica Prima edizione digitale 2013 Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu Italo ardito,a che giammai non posi Di svegliar dalle tombe I nostri padri? ed a parlar gli meni A questo secol morto,al quale incombe Tanta nebbia di tedio?1 INTRODUZIONE IL LETTORE DEL DE RE PUBLICA E LA BIBLIOTECA DI BORGES Il lettore del de re publicaintraprende un’esperienza che altre opere dell’antichità più raramente offrono:entra nel- l’avventura del manoscritto perduto e ritrovato dopo se- coli di ricerche,di speranze deluse e di silenzio;gode della sua restituzione alla luce,dovuta all’opera della fortuna, ma soprattutto dell’ingegno e della passione umanistica del leopardiano «Italo ardito» Angelo Mai,che scoprì2il testo nascosto,intravide le sue grandi ed eleganti lettere onciali raschiate e dilavate sotto il commento di Agostino ai Salmi;si meraviglia dell’ironia della sorte,perché pro- prio Agostino a cui dobbiamo gran parte della tradizione indiretta del dialogo ciceroniano abbia ispirato un mona- co del monasterio di Bobbio (verso l’anno 700) a oscurare Cicerone e a scempiare il suo bel libro.Si angoscia che la storia del manoscritto ritrovato,riconosciuto e decifrato, si complichi,poiché il monaco,o chiunque sia stato a can- cellare la primitiva scrittura del codice,lo disfece comple- 1G.Leopardi,Ad Angelo Mai,vv.1-5.La canzone fu composta nel gennaio del 1820 e pubblicata nel luglio dello stesso anno a Bologna, dove nel 1824 uscì una seconda edizione con una nuova redazione del- la lettera dedicatoria al conte Leonardo Trissino. 2Nel 1819 a Roma nella Biblioteca Vaticana;l’editio princepsè del 1822 (Roma-Stoccarda-Tubinga):cfr.Premessa al testo,pp.128-133. 6 INTRODUZIONE tamente e senza alcun riguardo,e dopo averne dilavato i fogli,riprese,a caso e senza ordine,solo quelli,circa un quarto dell’opera originale,che gli erano necessari per ri- copiarvi il Commentario di Agostino ai Salmi,numeran- doli secondo il suo testo.Considera una grave perdita il fatto che dell’opera,verisimilmente composta di circa ot- tanta quaternioni3per un totale di circa 1280 pagine,a noi rimangano 302 pagine,4 quindi meno della quarta parte dell’intero libro.Il lettore di fronte alle grandi lacu- ne che progressivamente si allargano a partire dall’ulti- ma parte del II libro,ma soprattutto dopo il §19 del III, proverà una pena,in seguito dolorosamente reiterata, per il fatto che dei circa quaranta quaternioni,5che veri- similmente ancora dovevano seguire dopo il XLI quater- nione,rimangano solo cinque fogli (10 pagine) più la par- ticulaindipendente del Somnium,di cui nessuna pagina è conservata dal palinsesto.È lecito allora al nostro letto- re,che ha seguito fin qui con comprensibili sforzo e im- pegno l’avventura e l’opera pietosa di ricostruzione (ol- tre tutto non sempre possibile) con i brevi lacerti di con- getture e di ipotesi più o meno probabili,chiedersi dove sia andata a finire l’altra parte,senza dubbio più grande, delle membrane del de re publica.Infatti la scrittura del codice prima bobbiense,poi Vaticano 5757,finisce prima del Commento di Agostino al salmo CXLI e termina con un foglio lacero,tuttavia l’autore arrivò sino al salmo CL; pertanto manca alla fine un terzo dell’opera, poiché quanti fogli abbiamo perso di Agostino,tanti del liber pulcherrimus et spissus6di Cicerone.Dice il Mai:«Un’al- 3Il quaternione era un fascicolo di quattro fogli ripiegato in due in modo da formare otto fogli e quindi sedici pagine. 4Ogni pagina del codice,divisa in due colonne,comprende 15 linee di scrittura ciascuna,complessivamente 30 righe,di cui ognuna com- posta di circa 10 lettere (da 9 a 12). 5Si veda la Premessa al testo per lo stato della sua conservazione. 6«Opera bellissima e densa»;cfr.Mai e Ziegler,sulla scorta di Cic. Quint.II 12,1:spissum sane opus et operosum. INTRODUZIONE 7 tra parte delle membrane del de re publica,senza dubbio più grande,fu impiegata o per scrivere il resto dell’opera di Agostino o per altri usi:in un solo volume non si pote- va concludere né l’opera di Cicerone né quella di Agosti- no».7Il Mai credette in seguito di aver trovato le prezio- se membrane del de re publicain due codici antichissimi: in un Vaticano del VII secolo e in un Vallicelliano del VI che contenevano il Commento di Agostino ai Salmi;ma la speranza dello studioso come subito si era accesa,su- bito si spense,appena si accorse che quei codici non era- no palinsesti e che,quindi,non potevano essergli di alcu- na utilità. A questo punto al lettore è lecito ancora chiedersi: dopo l’«Italo ardito» chi altri cercò di ritrovare nelle Bi- blioteche del Mondo le altre pagine anch’esse verisimil- mente rescriptae? Scriveva Sebastiano Timpanaro: «Quando si diradarono e poi cessarono le sue [del Mai] scoperte,forze nuove maturavano frattanto in altri cam- pi della cultura italiana;ma per gli studi classici comin- ciò il periodo della più grave decadenza».8 7Cfr.A.Mai,Roma 1846,p.XIX:Alia pars membranarum de rep. sine dubio maior vel rescribendo reliquo Augustini operi,vel aliis usi- bus adhibita fuit:uno certe volumine neque Tullii neque Augustini opus concludi potuit.Non pare possibile,in ogni caso,che il monaco che uti- lizzò i fogli del libro di Cicerone,data la penuria e il costo del materia- le scrittorio,abbia gettato via gli altri non utilizzati. 8S.Timpanaro,Angelo Mai,«Atene e Roma»,1956,pp.1-34 e IV, 1960,pp.90 ss.;poi in Aspetti e figure della cultura ottocentesca,Pisa 1980, pp.225-247;cfr.ancheAngelo Maie Sulla «Repubblica» di Cicerone,in Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento.II La Restaurazione,a cu- ra di P.Treves,Torino 1978,pp.347-363 e 435-443.L’affermazione di Tim- panaro è forse troppo severa alla prova dei fatti,considerando che i tem- pi successivi al Mai fino a tutto il XX secolo hanno visto all’opera valen- ti studiosi e filologi e la ricerca negli studi classici è continuata:anzi lo scorso secolo si è distinto per scoperte (in specie di papiri) di fondamen- tali opere greche e per conseguenti edizioni critiche.Sul de re publicari- sulta di particolare interesse la scoperta di C.A.Behr (cfr.«American Journal Philology»,XCV,2,1974,pp.141-149) di una citazione,ad opera di un anonimo scrittore greco bizantino interessato alla scienza politica, in un palinsesto Vaticano di Aristide,oggi Vaticanus graecus 1298,già 8 INTRODUZIONE Si può ritenere,considerando troppo severo il giudi- zio di Timpanaro,che l’avventura del manoscritto non si sia ad oggi ancora conclusa,e sperare che ancora una volta virtù e fortuna soccorrano gli studiosi nella ricerca e nella scoperta delle altre membrane. Quale codice le conterrà e quale altra opera le avrà ricoperte? Come localizzare il «venerando esagono se- greto»9che le ospita? Rimarrà forse al nostro lettore solo la «delirante idea» di cercarle nell’«Esagono Cremisi» di Borges? IL DE RE PUBLICAE LA BIBLIOTECA DI MONALDO E DI GIACOMO LEOPARDI.EPISTOLE FAMILIARI.I GIUDIZI DI GIACOMO LEOPARDI E DI PIETRO GIORDANI SUL DE RE PUBLICA Lasceremo questa domanda aperta per il lettore e noi ci chiuderemo alle spalle le porte dei labirinti di Bor- ges;tanta letteratura sulle Biblioteche ci insegna che esse sono luoghi pericolosi: la Biblioteca con i suoi scaffali e i suoi corridoi, immagine sia del labirinto della mente sia della memoria ordinata,è l’atempora- le faustiana tentazione alla conoscenza infinita,all’on- nipotenza e all’immortale giovinezza.Essa può essere, come dimostra il dottor Kien di Elias Canetti,in Auto da fé,anche trincea che solo apparentemente difende l’uomo dalla paura della vita e dell’amore,mentre ne distrugge l’interiorità,fino a ridurlo vuoto guscio,si- mile alla corazza che da solo l’infelice si è costruita addosso con tanta cura.Ma,almeno a Cicerone,a Pe- esaminato dal Mai,cui tale citazione era sfuggita.L’anonimo scrittore traduce in greco un passo,probabilmente dal V libro,che verteva sul rec- tor civitatise sulla struttura costituzionale auspicata da Cicerone nel mo- mento della crisi repubblicana;cfr.infra,pp.121-122. 9Questa citazione e le due successive sono tratte da La Biblioteca di Babeledi J.L.Borges. INTRODUZIONE 9 trarca,a Machiavelli10 e anche a Leopardi questo non capitò,a loro soccorse la ragione,cioè l’umanesimo, grande e forte scudo,che protegge dalle malattie del- l’anima,avvolge d’incanto e permette agli uomini di creare rapporti,di proiettare i loro affetti all’esterno, nella realtà delle persone e delle cose. E certo le biblioteche,i libri,i librai,gli editori,le ri- cerche di volumi introvabili o rari tramite amici o altri personaggi popolano le lettere di Cicerone,e di Petrar- ca,11che del manoscritto ciceroniano fu avido cercatore, come quelle di Giacomo Leopardi.Ogni Epistolario,co- me si sa,è preziosissima fonte dei tempi e degli eventi in cui è stato scritto,oltreché dei fatti biografici,dei senti- menti e delle passioni dell’autore;e in questo senso l’E- pistolariodi Giacomo Leopardi non solo illumina sulla storia della vita intellettuale italiana dei primi decenni dell’800,ma traccia nel contempo la storia di un’anima, si potrebbe dire di un’anima umanistica,che più di Ci- cerone e di Petrarca fece della Biblioteca il suo universo e la sua fede. Già in una lettera a Pietro Giordani scritta da Reca- 10Cfr.di Machiavelli la lettera XII,A Francesco Vettori(10 di- cembre 1513).Machiavelli,soprattutto nei Discorsi sopra laprima deca di Tito Livio,si accosta in maniera umanistica agli ideali del- l’antica Repubblica romana,pensando a un vivere sociale certo più alto e più nobile di quello presente.Lo stato d’animo di Machiavel- li dopo il crollo della Repubblica fiorentina nel 1512,da lui paven- tato e previsto con angoscia,e il suo conseguente ritiro nella solitu- dine e nello studio dei classici antichi lo avvicinano a Cicerone.Di- ce Arnaldo Momigliano (cfr.Pace e libertà nel mondo antico,Firen- ze 1996,p.27):«ci vollero circa dodici secoli di civiltà occidentale per riconquistare nei Comuni italiani i princípi del governo romano e dobbiamo forse arrivare a Machiavelli per trovare di nuovo una nuova esperienza politica fondata sulla repubblica romana». 11In tema di epistole ricordiamo che fu proprio il Petrarca a scoprire le tre raccolte delle lettere di Cicerone ad Brutum,adAtticum,ad Quin- tum fratremin un codice rinvenuto nel 1345 nella Capitolare di Verona. Il codice andò presto perduto come anche la copia che ne fece il Petrar- ca.Sul suo giudizio dopo la prima lettura,cfr.infra,p.126. 10 INTRODUZIONE nati il 30 aprile 1817,12tutta piena dei nomi di grandi uo- mini antichi e moderni,di giovanili fervori,di desiderio di gloria,di sdegni per l’ignoranza del natìo borgo sel- vaggio,il diciannovenne Giacomo sentiva stretti non so- lo il luogo natìo,ma perfino la biblioteca,pur grande, del padre Monaldo:«...con tutta la libreria io manco moltissimo di libri,non pure che mi piacerebbe leggere, ma che mi sarebbero necessari».A scorrere l’epistolario leopardiano,nonché gli elenchi di letture,la brama di li- bri appare come un’insopprimibile necessità,al modo di una fame che richieda di essere saziata con banchetti ricchi di raffinate vivande:viene in mente quell’aviditas legendiche Cicerone nella cornice al III libro del de fi- nibus(III,2,7-8) attribuisce a Marco Catone,13quando, mentre lui soggiorna a Tuscolo,recatosi alla villa del gio- vane Lucullo per consultare alcuni libri della biblioteca e per prenderli personalmente,lo trova«seduto nella bi- blioteca,circondato da molti libri di filosofi stoici» e co- sì lo descrive:«Era avido di leggere,e non poteva mai saziarsi...Tanto più nel tempo libero e in mezzo a quella enorme quantità di libri sembrava quasi ne facesse una scorpacciata,se mi è permesso usare questa parola in una tanto nobile occupazione».14 Nel banchetto leopardiano,ancora più abbondante,i volumi di Cicerone erano molti e fra questi non mancò neppure il de re publica.Nel catalogo della biblioteca di Leopardi infatti risulta l’edizione pubblicata a Roma nel 1822 e dell’acquisizione dell’opera ci informa lo stesso 12Cfr.Epist.60,pp.90-91,in Epistolario,a cura di F.Brioschi e P. Landi,Torino 1998,edizione cui si fa riferimento anche per le epistole citate infra. 13Marco Porcio Catone,stoico morto suicida a Utica nel 45 a.C., dopo la vittoria di Cesare in Africa. 14Cic.fin.III 2,7-8:vidi in bibliotheca sedentem multis circunfusum Stoicorum libris.Erat...in eo aviditas legendi,nec satiari poterat...Quo magis tum in summo otio maximaque copia quasi helluari libris,si hoc verbo in tam clara re utendum est,videbatur. INTRODUZIONE 11 Giacomo,a quel tempo a Roma,in una lettera del 10 gennaio 1823 indirizzata al fratello Carlo:«Mons.Mai mi ha mandato in dono una copia della Repubblica;cosa che è stata molto ammirata e invidiata,perché mons.non è solito a far questi regali,e parecchi per averne,l’hanno tentato e lusingato».15L’interesse per il de re publicari- sulta testimoniato anche da un inedito elenco di letture che emerge dall’archivio leopardiano,appunti autografi che Giacomo stesso sottrasse alla distruzione e che da circa un secolo sono conservati nella Biblioteca Nazio- nale di Napoli.Fra queste carte viene anche segnalato16 «un ignoto appunto bibliografico (un foglietto di mm. 49x94 utilizzato solo per il rectocon segnatura C.L.XXI. 9.4) dalla “Revue’’ [Encyclopédique]:M.Tullii Cic.de Republica libri etc.La République de Cicéron.Nouvelle édition de G.H.Moser,avec des notes par M.Creutzer. Francfort 1826.In 8°.Encyclopédique,tom.31,p.144. juillet 1826».Oltre a questo appunto,compaiono nell’e- lenco letture,varie ed eterogenee,riguardanti il setten- nio 1823-1830:17al n.3 due volumi di opere di Cicerone, al n.4 il de re publica,18al n.5 si trova scritto:«Idem,tra- duz.di T.Malvezzi» [Teresa Carniani Malvezzi].Riguar- do a quest’ultima lettura siamo informati da un’epistola dello stesso Giacomo scritta da Bologna all’editore A.F. Stella del 3 settembre 1826:19«Una contessa Malvezzi di 15Epist.494,p.620. 16Cfr.M.Andria,Le tracce della lettura.Un elenco inedito delle car- te napoletane,in I libri di Leopardi,«I Quaderni della Biblioteca Na- zionale di Napoli»,IX,2,Napoli 2000,pp.9-21;per la segnalazione cfr. ivi,p.10 n.4,p.11 fig.1. 17Cfr.M.Andria,cit.,pp.12-13 figg.1 e 2,e pp.15 ss.;e per gli elen- chi,cfr.G.Pacella,Elenchi di letture leopardiane,in G.Leopardi,Zi- baldone di pensieri,Milano 1991,III,pp.1137-1166. 18Non si sa a quale edizione il Leopardi si riferisca,si può pensare all’edizione in francese curata da Moser del 1826,come farebbe pre- supporre l’appunto precedentemente citato. 19Epist.984,p.1231.
Description: