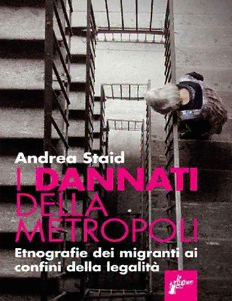
I dannati della metropoli. Etnografie dei migranti ai confini della legalità PDF
Preview I dannati della metropoli. Etnografie dei migranti ai confini della legalità
© 2014 Milieu edizioni © 2014 Andrea Staid www.milieuedizioni.it [email protected] Cover: Francesca Rossi Immagine in copertina: Gianmarco Rossi Montecuccoli Le fotografie presenti provengono dall’archivio privato di Gianmarco Rossi Montecuccoli Seguici su Facebook e Twitter Se tutti avessero una mela, rubarla costituirebbe un reato, ma in questa società, possedere la mela è reato e rubarla è un atto di giustizia. Ascanio Celestini PREFAZIONE F L C RANCO A ECLA Succede, a leggere questo libro, di rendersi conto della tragicità del presente in cui viviamo. I racconti degli intervistati, le loro cronache, gli eventi di cui sono vittime e protagonisti coloro di cui si parla, la stessa mappa vivente dell’immobile in viale Bligny a Milano ci restituiscono un mosaico che fa violenza al senso comune, che scuote per i costi umani che comporta e che ridisegna completamente il paesaggio dell’ovvio cui siamo abituati. Accanto alla nostra vita quotidiana, esiste un mondo solo apparentemente nascosto dalla nostra abitudine, in cui vivere è difficile, molto di più delle nostre cronache di crisi e di penuria. A due passi da noi, che siano le spiagge di Lampedusa o i viali “bene“ di Milano si muove la realtà nel suo sconquasso più assurdo. Gente come noi che fugge da paesi difficili più del nostro, e si trova per questo in situazioni impensabili e deve far fronte all’assurdità scegliendo una maniera per sopravvivere. Andrea Staid è tornato alle origini del fare antropologia, a quella scuola di Chicago che si interrogò nei primi decenni del Novecento sulle migliaia di hobos, di clochard, di senzatetto, di marginali e fuorilegge. Un approccio che ha fondato una tradizione di ricerca dove è fondamentale il coinvolgimento, ma che si astiene da qualunque romanticismo o da facili mitizzazioni. Per fotografare il presente con la lucidità e l’apertura di chi cerca di coglierne nella follia quotidiana i segni umani e disumani. Oggi c’è chi, come Bourgois e Schonberg, si occupa della nuova marginalità urbana negli Stati Uniti; chi come Jennifer Toth si cala nel sottosuolo di New York per riemergere con storie terribili di uomini e donne talpa che sopravvivono nel buio e nel freddo dei tunnel della metropoli. Staid ci conduce nel tunnel che inizia con la decisione di emigrare, con le tragedie nel deserto libico o altrove, con il pericolo e la morte in mare e arriva ai centri lager dove gli emigranti vengono ammassati e trattati come criminali. Fino a convincerli a diventar tali, a trovare un proprio modo di vivere nelle pieghe che la società prevede per i fuorilegge. E infine Staid ci porta tra le parole dei protagonisti, fino ai destini di marginalità e carcere. Sono storie disperate e disperanti, ma anche storie piene di vita, dove si capisce che l’immigrato dichiarato fuorilegge a un certo punto trova una propria ridefinizione dell’esserlo. Storie di immediata disillusione, di rivolta, di voglia di vivere nonostante. L’antropologia con la sua vocazione a testimoniare è uno strumento perfetto da questo punto di vista: ci costringe a renderci conto di come la vita quotidiana altrui non sia tanto differente dalla nostra, e nei panni dei marginali potremmo tranquillamente trovarci noi. In più, con una sottigliezza che Staid utilizza senza ideologismi, la marginalità stessa in queste storie viene anch’essa ridefinita. Si è marginali rispetto a una normalità che, se ristretta e ridotta, diventa un campo piuttosto ampio. Ci si “ritrova” a essere marginali anche non volendolo, quando dall’esterno le categorie di ammissione allo spazio sociale somigliano a quelle di un club per giocare a golf o a tennis. Nella tragedia dell’emigrazione verso l’Europa, oggi c’è la volontà precisa della politica europea di creare quelle che Foucault chiamava “eterotopie”. L’Europa come luogo che si serve della cittadinanza per limitare la dialettica sociale piuttosto che per arricchirla. L’Europa che gioca col fuoco approfittando delle diaspore mondiali ma che è poi incapace di gestirle. Le storie raccontate in questo libro dimostrano proprio che la gestione poliziesca dell’immigrazione non funziona nemmeno nelle sue intenzioni più repressive. Il flusso non si arresta e la nuova immigrazione trova vie di fuga che paga duramente, e che ampliano crisi sociale e conflitti sociali. Gli immigrati, lungi dall’essere carne sociale passiva, materia nuda da contrabbandare, sono soggetti che decidono di prendere atto della “non collocazione” a cui li destina l’Europa. Si inventano un ulteriore paese in cui emigrare, quello della marginalità o della delinquenza, del sottobosco urbano e se possibile della latitanza. Pensiamo a questa situazione su larga scala, a ciò che comporta a livello di destabilizzazione delle società, e poi chiediamoci se non sarebbe molto più intelligente ampliare lo spazio della cittadinanza europea. A meno che, ovviamente, in una visione negriana e delle sorti progressive degli sfruttati non si veda nella marginalità e nelle tragedie umane che ne conseguono la strada per la coscienza politica di un nuovo soggetto rivoluzionario. Tutte analisi magnifiche, che non tengono però in conto i costi umani che comportano né il fatto che i protagonisti di questa storia non vogliono essere eroi della nuova rivoluzione, ma pensano di avere semplicemente diritto a una vita decente. Leggendo le pagine di questo libro viene spesso da pensare al dibattito che proviene a noi da Hanna Arendt sulla cittadinanza e alle intuizioni di Giorgio Agamben sulla “nuda vita”. È vero, questi nuovi “non cittadini” sono gettati nello spazio indifferenziato del corpo nudo di chi non rappresenta che se stesso. È un corpo dolorante, affogato, riemerso a volte, un corpo che si mutila, che fugge, che cerca uno spazio dove nascondersi e proteggersi. Ma insistere sulla “nuda vita”, come osserva Lila Abu-Lughod (lo fa nell’ultimo libro, Do Muslim Women Need Saving?), porta anche a degli equivoci. Perché questi protagonisti e protagoniste dell’emigrazione non sono totalmente “tabula rasa”, portano con sé una storia e una dignità, una identità che non è solo “d’origine”. Le loro strategie di sopravvivenza, la loro tattica di re-insediamento e di nascondimento, il loro scegliere lo spazio della marginalità, avviene dentro a una appartenenza culturale e a un orizzonte di rapporti. La loro stessa possibilità di fuga dai centri lager è legata alla capacità di fare rete e di avere reti di solidarietà. Credo che il valore de I dannati della metropoli stia proprio in questo, nel mostrare molte di queste storie di vita, nel raccontare talmente da vicino il presente da non aver bisogno di un’ideologia di lettura; e avere la possibilità, invece, di tentare di capire entrando nella carne del mondo, nel suo essere così com’è e non come vorremmo che fosse. È la vocazione dell’antropologia, quella di privilegiare il “capire il mondo” sulla pretesa veloce di “cambiare il mondo”, o meglio, di mettere l’accento sui troppi errori di un transfert che operiamo “politicamente” sulle vite degli altri come materiale per il nostro desiderio di rivoluzione. INTRODUZIONE Questo lavoro nasce dalla volontà di analizzare con un metodo antropologico le storie e le scelte di quelle donne e di quegli uomini che vivono ai margini delle nostre città, che attraversano le nostre metropoli senza essere calcolati né ascoltati, fino a quando non finiscono sulle cronache dei giornali diventando oggetto di strumentalizzazione da parte di qualche politico, o giornalista di turno, che usa i loro nomi, o spesso solo i loro paesi di origine, per alimentare la politica della paura. Quella politica che si costruisce con leggi liberticide, tecniche di controllo sempre più accurate e pervasive, con la creazione di database in grado di schedare chiunque, con l’aumento di polizia e militari nelle strade, con la proliferazione del video controllo e la morte dello scambio culturale e della vita sociale. Troppo spesso nei nostri studi tendiamo a dare un’immagine dei migranti come degli schiavi volontari, in balia degli eventi, delle persone che accettano tutto per vivere, per mangiare e aiutare le loro famiglie rimaste in patria. Sono molti gli uomini e le donne migranti disposti ad accettare gradi estremi di sfruttamento, sopruso e autoritarismo, ma è anche vero, e allo stesso tempo è importante narrarlo, che sono molte le donne e gli uomini che decidono di rivoltarsi e di non accettare di essere schiavi. Sono convinto che l’antropologia sia un metodo, uno strumento troppo poliedrico per rimanere chiuso tra le mura accademiche; ritengo infatti che l’antropologia e la ricerca sul campo siano oggi, più che in passato, utili per analizzare e comprendere i mutamenti, le contraddizioni, i confini tra società legittima e società illegittima, i conflitti e le ibridazioni in atto nella nostra società contemporanea. La maggior parte delle persone, e degli stessi antropologi, non inquadra chiaramente il reale “stato d’emergenza” quotidiano in cui sono costretti a vivere gli individui socialmente vulnerabili; va constatato infatti che sono ancora pochi gli accademici che decidono di pubblicare o lavorare attraverso conversazioni e interviste non strutturate in quello che è il mondo della criminalità, nelle zone grigie delle nostre metropoli. È necessario indagare in quella giustapposizione di due mondi, o città, che coesistono ma si ignorano, o meglio si guardano, nonostante la prossimità, da una distanza insuperabile: la città legittima dei cittadini, dell’opinione pubblica, delle corporazioni e associazioni professionali, dei partiti e quella più o meno invisibile dell’illegittimità, dell’immigrazione, della micro-criminalità, della prostituzione palese o occulta, della tossicodipendenza. Due città ovviamente, in una posizione profondamente diversa e asimmetrica: la prima non conosce la seconda, ma la evoca in continuazione, ne fa la fonte di ogni disagio o, come si dice oggi, “degrado” urbano e civile, vedendovi il terreno di coltura di ogni possibile minaccia, popolandola di anormali e devianti; la seconda vive nell’ombra dell’economia informale, semi-legale o illegale, in luoghi scarsamente visibili dalla città legittima, e soprattutto non è dotata di voce. La città legittima pronuncia parole di paura e sospetto verso quella illegittima, ma ricorre a quest’ultima per un gran numero di servizi e prestazioni: dal lavoro domestico a quello in nero dei cantieri, dalla domanda dei vari tipi di prostituzione a quella di stupefacenti, gioco d’azzardo o credito illegale. La città illegittima è titolare di un’offerta di servizi la cui clientela è costituita in gran parte da membri della società legittima.1 Per conoscere meglio queste due città che convivono in una sola tra il novembre del 2008 e luglio 2013 ho trascorso molte delle mie giornate a stretto contatto con donne e uomini che vivono, attraversano, subiscono e si ribellano nelle città, nelle carceri e nei Cie italiani. I primi anni di ricerca, passati soprattutto con lavoratori migranti, hanno portato nel 2011 alla pubblicazione di un saggio di antropologia politica, Le nostre braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù;2 mentre a partire dalla primavera del 2012 ho indirizzato il mio studio su quella parte di migranti che preferisce delinquere che subire. Molto spesso in questi anni si sono sovrapposti i piani di ricerca, per questo nel libro troverete anche la voce di migranti che ho intervistato nel 2009 o nel 2011.
