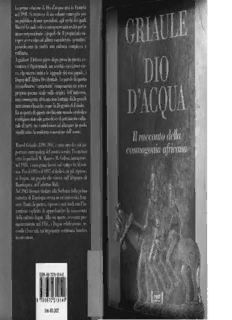
Dio d’acqua. Il racconto della cosmogonia africana PDF
Preview Dio d’acqua. Il racconto della cosmogonia africana
Introduzione di Francesco Paolo Campione La pritna edizione di Dio d'acqua uscì in Francia nel 1948. Si trattava di un volumc concepito per un pubblico di 1 non specialisti, agli occhi dei Marce1 Griaule voleva sottoporre iina realtà per lo meno sorprendente: i popoli che il pregilidizio europeo aveva sino ad allora considera- to 'primitivi' possedevano in realt8 un'otdinata e crierente iiietafisica che, attraverso un ingente complesso di con- nessioni simholichc, ne pcrmcava profondamente l'insie- me delle mcinifesr~tionci ultur,ili e che, per usare le prole dello stesso Griaule, epresentava il vantaggio di proiettar- ai in mille riti C gcsti su uni scena dove si muove una folla di uomini vivi.. L'interesse di Griatilc per i Dogon non era un fatto re- ccntc. Il siici primi~c ontatto inarcrialc ccin il p~polod el- I'iilripinno di R;indiiigarn risaliva n clici:rsscttc anni prima. A qucll'cpnca, l'ecnologo francese, da poco passata la treiitiria, si trovava a .capo di un pr~~ger(tloa celehre tiiis- sionc thkar-Gihiiti) dclibcrato, con iinil legge ad hoc, dal Parlamento francese il 31 marzo del 193 1. Si trattava di un'iinpresa collettiva concepita, per la prima volta, se- ccincici un programma di ricerca sul canipo affidato a spc- cialisti con iina formazione scientifica di carattere antru- pologico. Nel corso di ventidue mesi, l'équipe guidata da (;riaiile (e della quale faccvano partc Marccl Largcc, Mi- che1 Leiris, Deborah Lifszyc, Eric Lutten, Jean Muuchey, Gaston-Louis Roux e André Schaeffner) avrebbe dovuro porre le basi di iin programma di studi a lungo tcrrnine sulle culture africane, in particolare di quelle insediate nei territori dell'allora Africa Occidentale e Africa Equa- toriale francese e dell'Eciopia. Essa era inoltre incaricata di provvedere aila raccolta di oggetti e opere d'arte che 7 Dio d'acqua avrebbero dovuto accrescere le collezioni del Museo Et- l In secondo Luogo, l'altipiano di Bandiagara (area rag- nografico del Trctcadero (oggi Muske de 1'Homme). gi~ngihilese nza fatica coi mezzi di trasporto allora dispo- L'équipe guidata da Griaule giunse una priina volta in i nibili) coi siioi villaggi geograficamente cwsi e la sua po- vista della regione montagnosa di Bandiagara il 17 set- polazione di circa 200-250 000 persone, rappresentava un rembre del 1931 C risiedette ininterrottamente a Sanga e l ambito di studio estremamente vantaggioso: senza doversi nei villaggi vicini dal 28 settembre al t 9 novembre (Lei- sobbarcare I'oncrc di grandi spostamenti, il ricercatore ris, 1951, pagg. 96-129). Nel cotso di questi primi due poteva, con relativa facilità, raccogliere e confrontare di- mesi di lavoro apparve evidente, a Griaule come ai suoi verse testimonianze su di un unico argomento, e indivì- compagni di lavoro, la singolarità e la ricchezza di una duare con buona precisione i rapporti con gli oggetti e cultura che aveva saputo elaborare e difendere, in un am- con gli eventi cui queste si riferivano e, in definitiva, biente dalle risorse estremamente limitate, un sistema di coniporre così iin quadro comparativamente vasto cd vita inateriale e spirituale di altissima qiialità: esaustivo. Lo stesso dicasi per i riti o per le espressioni del- l la cultura materiale e delle fortne dell'arce. La letteratura *Al conlronro di qucsta gcnte, turco ciil che coiiosciatno a pro- scientifica sull'argomento si limitava a qualche scritto di posito di negri ci di bianchi ci semhra che assoniipli a mascalzo- carattere gcncralc di Arnoud e Leo Frobenius, il che cun- ni, a canaglie, a lugubri huffmi. Religiositb frtrtnidahile. I1 sacro correva a dare alla ricerca I'impimtur di un'assoluta no- tr,rsiicI;i da tutti i pori. Q i i ic osa appare sagcia e graven (Leiris, v irA. Non bisogna infine sott«valii tare clie i francesi, inol- l95 l, p;~g.9 7). I tre, potevano contare sul sostegno logbcico e struinentale Vitte la pena qui sottolineare clie le circostanze della ri- dt.II'Ainrnitiiscrazionec oloniale, di cui, fatte le dovute di- cerca presso I Dogcin si presentavano allora particolar- stinzioni, crsno incvicahilniente aiich'cssi in qualche rncntc hvorcvoli, c qiiesto per diversi tncirivi. 1 miiclo espressione. In primo luogo, nonosrantc I'occiipazicine inili care frati- Infine, fatto di gran Iiingn prcinincntc, per quanto ri- ccsc iivesse provocarci irievitahili friistr;izioni, c i contatti guardava il patrimonio ideologicu ci si poteva avvalcre con gli europci qua lchc modificazione tiei costunii locali, del sosceglici cli una vera e propria clnsse di notahili cnidiri la spinta acculturnnte dell'Occidcntc non aveva ancora il ciii intcressc nci confronti dclla propria cultura si carat- i prodotto effetti degeneracivi sulla strrittura portante della I terizzava in base alle attitudini C alla persoiialc disposizio- civilth endogcna, cosa che sarebbe avvenuta, iii verità a ne psicologica e, negli anni, si accresceva a contatto con ritmo meno sostenuto che altrove, sciltanto a partire dalla gli altri sapicnti. A calc caratteristica della cultura dogon, seconda merà degli aniii Sessanta. I dati in nostro posscsso Griaule dedicò specificaniente un suo scritto (Griaule, ci permettono anzi di ipotizzare che le ricerche di Griaule 1952), in cui troviamo, fra l'altro, anche un clenco degli e di coloro che ne seguirono le orme si svolsero in quella anziani informatori che erano a quell'epoca praticamente particolare situazione che David B. Queen (1961, pag. 46) in .grado di padroneggiare i limiti e la natura della cono- ha definito col nome di exploration (ricogt~izionec ultura- scenza tradizio~iale. le), che comporta iin rapporto pacifico fra culture che non Non deve quindi nicravigliare se da una missione ini- hanno strutturato il conflitto, più o meno vinlcnto, quale zialmente concepita sotto un profilo semi-continentale, piano di incontro, e dunque nella più favorevole delle for- sortì un programma di ricerche forremente indirizzato in me di acciilturazione, appena olrre l'integrazione. I chiave monografica. Di ritorno in Francia, l'obiettivo pri- Dio Sncqiln tnario delle ricerche di Griaule divenne, come ha giusta I colloqui che Griaule, nell'ottobre-novembre di quel- mente fatto notare Alfred Adler, qtiello di: l'anno, ebbe con Ogotemrneli, un vecchio cacciatore cieco, ritenuto fra i pih alti deposirari della tradizione *costituire lin corpus di conoscenze il più cnnipleto possibile, dogon, costituirono in tal senso un'evento inaspettato capace di racchiudere in una rotalità significante la cultura ma- teriale, i comporrarncnci sociali, i riti e, attraverso le credenze che produsse un sostanziale mutamento delle convinzio- i miri, i sistemi di rappresentazione religiosa e metafisica che n, ni scientifiche dell'autore: sino a quel momento, infatti, sono Ia premessa. (Adler, 1991, pag. 3 10). nel tentativo di ricostruire un quadro di riferimento ge- nerale, lo studioso si era avvalso dei propri enunciati e Fra il 1931 ed il 1937, Griaule soggioniii altre tre volte dei propri ragionamenti scientifici per addentrarsi nel- presso i Dogon. Friittci di questa prima case di studi furono l'universo apparentemente disordinato dei miti e dclle le due monografie Jeux dogons e Masqurs dogons pubblica- concezioni ideologiche africane. La lunga esposizione di te, nel 1938, nellc Memorie delllInstirut J'Ethnologie di I, Ogotemmeli mise invece a nudo una cosmologia siste- , 1, . ,, . Parigi. In qiiesce due opere prese forina l'imposr~zioiie' I matica presentata sccondo il punto di vista dclllAltro. milrodologica che rimarrà poi legata al nome dell'etnolo- La somma delle conoscente scientifiche sino ad allora go francese. Per Griaulc, I'etncilogia ccistituiva il prcidotcci acqiiisite non fu più l'oggetto della ricerca ma, in funzio- 'di un (~conglomentndi dirciplineb) (Griaiile & Uieterlen, ne strumentale, divenne una chiave per acccdere a una 1957) ciascuna dclle quali contribiiiva, sccondo il proprio forma di conoscenza più alta, a una visione del niondo indirizzo specifico, ad csplorarc ipotcsi cli lavoro che tro- ordinata e armonizzata da un coerente sistema metaficì- vavano nclle concezioni mitoloRichc c ideologiche (e in co, e dotata di una razionalitl sua prcipria. Per di più, se- p;irticol;irc. tielle cosrnogonic) un punto di riferimento condo Gtiaule, tale visione contrihiiiva non soltanto a privilcgi;ito. L'ctiiiilogci, lungi d~ll'esserci~ iiiusr l dare spiegazioni esaurienri sulle sccltc sociali ed esisrene doveva essere in grado di paclton~~~iinl rpeiì i ;i ziali dell'uomo dogon, ma poteva utiliiiente essere aclo- vero cli con\petenzc, orientando in pritrio luogo la sua uc- pcraca anche p r i nterpretare fenomeni estranei a quella tivitiì alla ricerca c ;il recupero della cornlit?~d elle fi~nti. culrlin. L'infliieiizcl iIi Criaulc si co~icretizzìia, ,p artire cI:iIl:i tneth Da questo mutamento di fondo, nonché da un intimo dcgfi anni Trenta, iiei lavori di iinrì serie di ricerc;itori che fastidio per l'etnocentrismo della cultura occidentale, npptofolicl irono gli sttidi nei diversi campi della ciiltura proviene in buotia parte la scelta di divulgare lo studiii al clogon, facendone nel complesso uria delle meglio cotia- grande piibblico (Dio d'acqua, XXXII giornata): sciiiti: del mondo non-occidentale. Fra i principali ricor- diamo Germainc Diererleii, Denisc Paulme, Solange dc .Non cra, infatti, convenuto una volta per cuttc che il Nero Gonay e Genevieve Calame-Griaule. non poteva dare alcun apporto alla cultura, e che non poteva Dopo l'intervallo bellico, Griaiile, che nel 1943 era nel nemmeno riflenere forme antiche del pensiero del mondo? Non cra stato relegato, in ogni tempo, al rango di schiavo? frattempo stato nominato professore di Ernologia genera- 'Guardate i bassorilievi scolpiti dalle civilci drll'ancichi- le alla Sorhona, organizzò una nuova riccrca sul cainpo; nel 1946 era di nuovo a Sanga. A giudizio di molti dei th! Dove soiio i negri? Al loro posto! Fra la gente di poco cnn- to! Che influenza volete. attribuire loro?'~ suoi collaboratori, le sue intenzioni erano allora soprat- tutto qiielle di precisare e verificare la cospicua inesse di La scelta di Griaule fu indubbiamente felice. Dio d'acqua infortnazioni già acquisire. conobbe un riotevole successo e fu tradotto in parecchie 10 ideologico di chi lo esprime, soltanto una frazione urga* linguc. Ogotemmeli divenne per molti una mrta di Orne- nizzata di credenze (Sperber, 1984, pag. 68). E che se an- ro negro, un simholn escmplare della saggezza africana. Anche da un punto di vista scientifico, il Lavoro di che, per ipo~csrie mota, tale parte cosc~tuissei n realtà l'in- Griaule ebbe immediati riconoscimenti, contribuendo, tero universo delle conoscenze individual~,d ovtetnmo fra l'altro, in inodo decislvo a stimolare ricerche di carat- p~imad i tutto interrogarci sugli scopi e Le modalità della tere s~stematicosu lla mentalità e sulla filosofia africana. sua organizzazione e sul significato stesso della nozione di Tali ricerche erano srate inaugurate da uno studio del pa- credenza che presuppone. Allo stato attuale della ricerca, dre francescano olandese Plactde Tempels ( 1948). Questi, inoltre, resta ancora da dimostrare che la ciiltura sia al suo a parcirc dalla disamina metodica dei discorsi e dei com- interno un tutto unico, e non sia invece, per esempio, portamenti rilevati in quasi due decenni di permanenza come ha proposto Clifford Geerz (1973), qualcosa di so- presso i BaLuba {un popolo dello Zaire), aveva tentato di stanzialmente distinto dalla struttura sociale tt dalla psico- delineare un'ipotesi del sistema più generale cui obbediva logia individuale. In questo secc>ndoc aso, sarebbe quanto il loro pensiero. Fra le altre opere di'maggi»r rilievo ticor- mai interesan te verificare in che rapporto stanno fra loro diamo: Essai sur la religion hambara di Germain Dieterlen l'aspetto cognitivo e I'cthos nella visiune del inondo del 1950; Divine Hmsernen. Tk Liuing Gods of Haiti del espressa dal saggio di Bandlagara. 1953 di Maya Deren, un'ex attrice americana iniziata alle Paraclossalinciite, l'aspetto sistematico delle rivelazioni dottrine misteriche del voudou hartiano; La philosophie cli Ogoternmeli, ci<')c he costitu] allora la iiovit5 della ri- bantu-reuandaise de 1'Erre di Alexis Kagame del 1956, ope- cerca e la genialith iiitriiisecs dcll'opera, nc risulta oggi, ra in cui un hantu (poi divenuto uno dei maggiori espo- da un punto di vista scientifico, la parte piìi prublemririca. nenti dell'antropolcigia africana) riflette e appr«fondisce Anche riguardo al contenuto niecodologico del discorso il complesso on tologico appreso negli anni della sua edu- c all'interpretazione clci dati è opportuno che 11 lettore cazione tradizion;ilc (Jahn, 1975, pagg. 105- 106). Lo sces- non specialista tenga contci di alcuni elementi di giudizio. so Griaule continuò a lavorare con passione su questa La cultura dcl villaggi», in cui si muove (;rinulc nel cor- strada, pubblicalido iiumemhi siggi e mettendo mano, in- so di tutta la sua narrazione, c che racchiude in sé l'idea sieme a Gcrmaine Dieterlen, a uiio studio munumentale dcl mondo, ng~id,i fi~tton, on esiste piu, ti6 in Africa, n6 chi avrebbe clovuto costituire Ia summa mitologica della altrove. Coma ha scritto llanrropologo Alì AI'Amin cultiira dogon. Di tale opera, bruscamente interrotta dalla Mazrui (1986, pag. 295): morte di Griaulc, awenuta a Parigi il 23 fehbraio 1956, la ~Cicbli e l'Africa ha spcrimci.itato nel corso di questo secolo 2 Dieterlen piibblicb nel 1965 il primo volume (Griaule & stata soprattutto la consirlercvole traiisizione Jal eiilluggio globa- Dieccrlen, 1965). lizzuto ('il mio popolo è il mondo') al mondo ~illu~zza(t'oil po, polo del mondo 6 il mio popolo'). Un violento shock ha scosso Oggi, naturalmente, a distanza di quasi cinquant'anni dal- in profondità il cr~nrincntec,h e a iin tratto ha dovuto prendere la sua pubblicazione, occorre premettere alla riedizione coscien:a che il villaggio non cra pii1 il mondo e che, anzi, il dell'opera alcune considerazioni. monclo era divenuto un villaggio. Il concecro di villaggio globa- La primi riguarda l'impianto stesso della ricerca. stato le divenuto familiare, e l'idea che il pianeta Terra è un'isola infarti giustamente notatu che anche il sistema cosmolo- solitaria nel cos~noè entrata in competizione con i più antichi miti e le più antiche leggende dell'tifrica~. gico più ampio e articolato è, all'interno del patrimonio DIOd 'acqua Questo stato dì cose ha inevitabilmente comportato una Il valore della testimonianza di Ogotemmeli rimane da un revisione profonda del patrimonio ideologico tradizionale punto di vista metodologico q~ialcosad i difficiilmente de- e una serie di ribaltamenti simbolici e di niiove colloca- finibile, in articolare è arduo determinare quanta parte zioni concettuali, i cui esiti sono ancora in atto. del suo raccotitn appartenga effettivamente alla trddizio- ne orale, e cioè a fonti riferite e trasmesse nel tempo dì 1 La maggior parte degli apparati concettuali di cui Griaule bocca in bocca, e quanto sia invece frutto di una persona- I si serve per introdurre alcune sue deduzioni scientifiche le interpretazione e rilettura del patrimonio delle cono- I sono dar considerare soprattutto come elementi utili alla sccnze cnllettive. Qua e tà, durante i colloqui sembra di ricostruzione di una storia dei pensiero etno-antropologi- poter cogliere elementi che appartengono a tipologie co- ' co. In particolare, Griaule adopera il concetto di 'cotcmi- riosciute di tradizioni orali, come forinule semplici (titoli, smo' nel senso di una concezione religiosa per cui una se- slogan, formule religiose, eccetera), genealogie e storie rie di usante di certi gruppi umani vengono assimilate a narrative condivise, ma la mancanza di riscontri certi specie animali, non necessariamente reali. Come dimo- mantiene queste percezioni a livello di semplici congetcu- strò Claiide Levi-Strauss in suo celebre volumetto del re. Non si tratta di un problema di poco conto. Le ricer- 1962, tale concezione era in realta una distorsione arbi- che sullc tr~diziunci di, a partire dagli scudi condotti da traria di elementi che avevano una portata di gran lunga Jan Vansina all'inizio degli anni Sessanta, ne hanno infat- più ampia. 1 fenotiieni cosiddetti 'totcmici' traducevaho ti clirnostrato I'attcndihilirh come fonti per la ricoscruzio- I1opposizi«nc di due ordini, quello animale e quello uma- nc della storia. E quanto questci sia imporrantc per lc cul- no, in cui attraverso la percezione dei caratteri delle diffe- tiire afric:tne, che non dispongonc) di documenti scritti renze fra Le spccic animali (tnodello) gli individui di una del loro passato, L\ immcdiaramentc chiaro per tutti. Inol- cultura riuscivano a concettualizzare e darsi contci della tre, Ic tradizioni orali per poter essere impiegate coine complcssiti del proprio ordine scxiale. Lo stesso discorso fonti devono poter rispondere ad una serie di requisiti - vnlc per quanto riguardi1 la percezione della regolarita (Vansiiia, 1976, pagc. 6 1 199), che non sono purtroppo nella forina e ncl contenuto dci initi che, secondo l1ipote- cieducihili dnlllimpcist:izione inctidologica di Criaulc. Cib si strutturalisra, deriv:ino dalla presenza di schemi logici c noli toglie, ben inreso, alcun valore dociimentario alla te- di proprieth gencrali sccondo le quali procede t: si articola stimonianza di Ogoteiiitneli, mi1 ne veicola in campo il pensiero umano. ctno-storico la rilcvanza specifica. E iiiolto argura, a tal proposito, la risposta data da Griaiile (Prefazione) a chi La ricerca di Grialile s'inreressa sopnttlitto al risvolto repiirara le iiiformazi«ni del venerabile dogon *spcciila- ' astrarto dei sisteini ideologici, preoccupandosi poco di ve- zioni individilali di interesse secondario*, ma pone seri rificar~la presenza di propriet8 esterne al racconto mito- interrogativi riguardo all'uso estensivo (e comparativo) logico, nemmeno quando, come ha fatto notare Francoise dei dati dedotti dalla testimonianza. Miche[-Jones ( 1978))q ueste sarehbero potute derivare rla un confronto fra i dati forniti dalllinformarore e quelli Occorre infine riconosccrc, come hanno fatto anche i piì~ provenienti dall'osservazione dei comportamenti quoti- alri estiinarori della sua opera (Hazoumé, 1957, pag. 175), diani e dai fatti della ciilnira materiale. che Griaule avrebbe senz'alcro rrntti, vantaggio dalla co- noscenza diretta della lingua dogon (nel corso dei suoi Diri d'acqua delle siie articolazioni interne, il sistema simbolico presen- colloqiii, si servì sempre di interpreti), in particolare per tato da Ogotemtneli e l'interpretazione di Griaule sembra- stabilire utili connessioni fra il significato gciierale e qiiel- no dunque ofYrire prospettive d'indagine molto inceressan- lo letterale della testiinonianza. ti, specie sc consideriamo che, alla luce di recenti teorie semiologiche del siinholisnio, o di interprecazioni antropo- Detro questo, non vorremmo che si avcssc la tcncazione logiche che privilegiano l'aspetto motivarionale, le stesse di confinare esclusivamente Dio d'acqua fra i 'classici' del elencazioni da cui abbiamo tratto spunto dovrebbero in- pnsicro ernoantropologico. L'opera di Griaule possiede durre il ricercatore a trovare un codice significante o ad ancora oggi una vitalità insospcttata, sulla qualc crcdo sia addentrarsi in iina difficile (e spesso infruttiiosa) ricerca opportuno soffermarsi. del valore di ciascun segno nell'esperienza collettiva. Il mondo di Ogotemrneli, così come scatiirisce dalla Se il carattere ordinato del 'siscema del mondo' affresca- lunga serie di collctqui che costituiscono I'oggct.ro di quc- to da Ogotemmeli non piiò pretendere di esaurire I'uni- sto volunie, sc noli pub essere cunsiderato con certezza il verso delle rappresentazioni simboliche dogonlc i permet- prodocro di una serie di tradizioni oralr, pub essere senz'al- te senz'altro di riflettere in profondith sul valore dei lega- cro considerato nei termini di uii1etnof»ntco ralc non for- rnalizzata, e ci06 di un docuiiientci etnostc.rico in grado di mi che Ic~anoI' iiomo t la sua cultura alllarnbiente che lo circunda. La nustm quotidiana ebperienza esistenziale ci restituire importanti informazioni siille dinamiche inter- porta a distingucrc i meccanismi sociali dalle rcgolc e dal ne della cultura clogun, e cli contribuire epistcmologicn- dclicato equilibrio della natura di cui facciamo biologica- mente alla ricostriizionc di una storia inregr;iIe (e qiiiiidi iiiencc parte. In questo iiiodo, cunitl Iia scrirtci Giovanna anche cleltt mentalitfi) del contesti socio-culnirali clic Io Anrongini ( 1982, pag. 263): hanno prodorto (Rigoli, 1995). Le relazioni che inrcrcorrono fra gli elcmcnti simbolici u? divcriiiito per ocii cstmneci e cluiisi inci)iiipr~h~ibiill cil iiwlo in de1l;i n:irrazionc di Ogcitcmineli non hanno significato cui tante dcllc wcicth :iltrc integrano C codificano nel vivcre, solo in conformirh dcl loro iispctto sisteinarico, 116, solinit- nei iiiit i e nei rittiiili ];i profoncl:~c cinosccnzij e ct~mprcnsionc tiitto, sono consiclerate, sia nelle p:irolc del vci-icrnhilc do- del Icgamc con 1':irnhicnrc nnrur-alt. Ncl montlo clogon, I1c.cosi- toii, sia nell'csposizione di Griaulc, esclusivrimente alla srtBmi~i al~Il'ian sieinc delle rappresentazioni, cjssia il nitto, in un scrcgua di 'segni'. Le parti sisternarichc ilel discorso di mosaico compiuto di ciii in genere iioi reiidiatno a coiisidersre Ogoternmeti s&o, per esenipio, spesso prcccdutc da com- le siiicole tesscre-. plesse eleiicaziotii di concordanze sinibolichc, di carattere Elemento unificante di qucsca concczionc pcr i Dogon prevalcnrcmente analogico. In questi casi, piucrosto che la Purola, che possietle al contempo una fiinziune merafi- soffermarsi sull'analisi dei significati crrnplessi clze scm- brano trasparire dagli enunciati, Griaiile preferisce con- sica C iin valore sociale, e inrerviene ai diversi livelli del- l'esperienza quotidiana e delle dinamiche culturali. centrare Ea sua artentione sulla spiegazione che ne segue, Infine, le quiilicà letterarie del vulume, oltre a renderne foriiira tlal siio informatore, e sulle sue considcrationi che ne derivano di conseguenza. In qualche modo egli antepo- piacevole la let tiira, contribuiscono a rest iruire sfumatiire e percezioni ncgatc al resoconto arido, anchc se policically ne cioè valutazioni di carattere psicologico, per le quali il correct, di tanta parte clell'antropologia contemporanea. simbolismo è considerato in certi casi come un facto indi- LJosservatore non è mai neutro: nel corso delle sue ricer- viduale, alle necessit8 di una teoria del simbolo. Al livello che egli interviene non solo con gli strumenti del proprio Miche1,Jories (1978) Retnur aux Dogon, Lc Sycomore, Parigi. mestiere, ma interagisce con tutto il carico della sensibili- E. Morin (I.990) Inrroductioii a b pensée compkxh BFqP arigi. ta umana di cui è portatore. Escludere qucstlii!tima parte, D.B. Queen ( L96 1) Exphration nnd Exmiun of Europe, Rourledgc, come ha scritto Edgard Morin, significa privare il proprio Londra. lavoro della ricchezza della complessità di avvenimenti, A. Rignli (1995) Le ragioni dell'emostotia, Ila Palma. Palermo. D. Sperber (1984) 11 sapere h& anmopob~F, cltrinrlli, Milano. azioni, retroazioni, determinazioni e rischi che costituisco- I! Tern~l(s1 948) Lo philosophie banrt~P~r,e sente africaine, Parigi, con no il nostro mondo di fenomeni (Morin, 1990, pag. 21). una Intr<xliizione( Niani M'Paya) di Alioune Diop. In questo senso, il valore della grande lezione dell'etno- J. Vansina ( 1976) h nadinont! M&. Saggio di mel»duIogi~1s tmica, edizio- logia da taccuino, che ha avuto in Francia esponenti del ne italiana aggiornata con un nuovo saggio dell'autorc, Officina Wizio- calibro di Griaule, di Leiris e del LCvi0Stratiss di Tristi no- n;. Koma. pici, e chc non trova corrispondenza nella letteratura an- tropologica italiana, se non in certe pagine di Fosco Ma- + raini. ancora tutta da scoprire. RIBLICX.ÌRAFIA CITATA A. Aillrr (1991) (ìruiuh, i n. 'f hiitc Pirrrc & M. [zaril (a ciira di) I)ictiii~owire& I'ethnnloK;~rt cL? ~'on~hrf~~P~relsose~s iIe;i.ii vcrsit:iires de Francc, Parici. p:igg. 709- 7 10. G. Anron~ini( 1962) 11 cmnmirici dch l>or&. in C;. Calnmr-Griniilc JI mondn dclh prnln. Ernnh~ine l i i i ~ ~dieio cl u~r<R~.~iIiI,: iti Roriti#hit.ri, Tirino, p;i~g2. 61 -270. (.i. Uilanic Gri:iiiI~( 1985) rtt~uiir-prfip:i~ Dicu J'cmc. Enrctbis rmcc O~v~tcrnin?Flin, y:iril, i':tri~i. C. ticcrz { 1973) Thc~I nmptrtrticin ci/ Cul~ures.S alucnd Essnys, Rnnic h k s ,N cw York (ir:irl. ir. Itirc.iprt~~i;innrd r crtlture, Il Miilino, Uolo~n:i, 1987). M. (;riiiiilc ( 1952) t! siiuoir des lh~mii,i 'ji)urn:il dc IR Swit(t4 tles Africariisres', \.ol, XXI1, Parigi. M. Griaulc & C;. Dicrtrlcn (1957)M c'think. <L. I'rthiii~firaphie,P rcsses Univcrsitaircs dc Frnnce, Parici. (1965) La rrnnrd @le, tcirno I, fascicolo I, Institiir d'Erhnologie, Parigi. P. I IazournC (1957) Marcèl Grialrk, I'afiic!iin, in al. vv. Mnrrel Griuule. Cmeibd ri l'llninn fruryraisc, Nouvelles Editions Latines, Parigi. pagg. 173-1 76. J. Jahn (1975) Muntu. h civiltil africana mcdrma, Eiiiauili. Torino. M. Leiris ( I95 l) L'A/riqw fnnl8rne. De Dakar d Djihtri, 193 1-1933, Gallimard, Parigi. C. Lbvi-Smiis.. (1962) Le torkiiisinr utrj~t(~d'hiPrir.e sses Univcaitaires dc Francc, Parigi (trad. ir. l1 tocemisrno ollgi, Feltrinelli, Milano, 1964). A.A. Ma:tui (1986) Th Aficnns. .4 Triple Heriu~~Lei,t rle, Brown E; Co.. Bosron. DIO D'ACQUA Prefazione In uno cltii più stupefacenti caos di rocce dell'Africa, vive di contadini guerrieri che fu uno degli ultimi. nel doininio (colotiiale) francese, a perdere la sua indi- rcndenz;i. Per la maggior parte dei Bianchi dell'Africa Occidenta- le,i Dugoti sono uoinini pericolosi, forse i più arretrati clclla Federazione. Haniio faina di praticare ancora sacrifi- ci iimnni e di difendersi tanto meglio cunrro le influenze csrcme in qiianto abitano un paese difficile. Alcuni lette- i;iti hanno raccontato le loro piccole paure nel corso di spedizioni clie supponevano tememrio. Siilla hsc di que- ste Icggcnclc e con il pretesto di stimmosse dovute spesso ;i dei nialintvsi, interi villag~is ono rimasti tiilvulrs totai- mente isol;iti. In breve, i Dogon rappresenterchhero tino dei pib hegli esempi (li scrlvnggin primitivit?~e; questa opinione è con- KURUMRA -. 14" divisa da certi Ncri inusulinani clic, inicllettualnience, nirude 4D yvdG~ non sotio tiicglio conformaci dei Bianchi per giudici~rc I ,Td ~fo quelli, Cm i loro fratelli, che sotio rimasti feclcli alle cradi- 1ZEGIONE DEI DOGON ziutii aricestriali, Solo i funzionari clie si sono assutici il e scala kin UAHI(;UtIIA gravoso compito di amministrare questi uomini hanno ob 51) 100 iinparato ad aniarli. I..';~utored i questo libro e i siioi numerosi collaboratori la reRione abica~ad ai Dopn freqiientano i Dogon da una quindici~iad 'anni. Hanno piihblicato su di loro sciidi che ne fanno attualmente il popolo meglio conosciuto dellVAfricaO ccidentea I e f rance- se: Les Ames des ilogon (G. Dieterlen, 194l ),I ,es devises des Dogon (S. De Ganay, I941), Masques dogons (M. Criaule, 1938); lianno portato alla cultura la prova che i Neri vivono secondo idcc complesse, ma ordinate, e se- condo siscemi di istituzioni e di riti nei quali nulla è la-
Description: