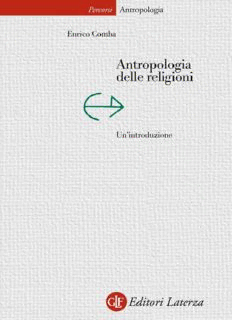
Antropologia delle religioni. Un'introduzione PDF
Preview Antropologia delle religioni. Un'introduzione
eBook Laterza Enrico Comba Antropologia delle religioni Un'introduzione © 2008, Gius. Laterza & Figli Edizione digitale: giugno 2014 www.laterza.it Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy) per conto della Gius. Laterza & Figli Spa ISBN 9788858114285 È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata Sommario Premessa I. Un intreccio di sguardi: religioni e complessità 1. Esperienza religiosa e tradizione 2. Conoscenza e potere 3. Che cos’è la religione? 4. Uno sguardo sulla complessità 5. Religioni e popoli indigeni 6. Un’epistemologia del rispetto 7. Esplorare la complessità II. Dalle forme elementari della religione alla complessità dei sistemi simbolici 1. La ricerca delle forme elementari 2. I Bororo e i pappagalli 3. Mauss e la strada verso la complessità 4. L’ordine dei simboli e il potere del disordine 5. Dialogo con gli Aborigeni III. Alla ricerca della «visione del nativo» 1. Intermezzo dogon 2. La cultura attraverso gli occhi del nativo 3. Religione, individuo e società 4. Sciamani e «bricconi» mitologici 5. L’individuo come sistema religioso complesso IV. Universi religiosi e pratiche della violenza 1. Religioni e violenza 2. La violenza originaria 3. L’iniziazione 4. Il sacrificio e la caccia 5. Guerra e identità V. La creatività del sacro: trasformazione del sé e ricreazione del cosmo 1. Credenze e razionalità 2. Meccanismi cognitivi 3. Ciò che mostra l’angelo dei sogni 4. Lo sciamano, esploratore dei limiti 5. Costruire e ri-costruire il mondo Conclusione Bibliografia I. Opere citate II. Selezione di monografie etnografiche 1. Africa 2. Le Americhe 3. Asia 4. Oceania Premessa Gran parte dei problemi che vengono discussi in questo volume si sono presentati, in modo più o meno definito, nel giugno del 2005, mentre mi trovavo nella riserva di Hannaville, nello stato del Michigan, in un angolo sperduto in mezzo a colline e pianori boscosi, dove si stava celebrando un pow-wow. La parata stava per avere inizio e i partecipanti venivano invitati dall’altoparlante a sfilare. Le prime file erano formate da un gruppo di veterani che avevano preso parte agli ultimi conflitti bellici con l’uniforme dell’esercito americano, dalla guerra del Vietnam alla guerra del Golfo: le bandiere, le decorazioni e le medaglie si combinavano con i costumi tradizionali e le insegne variopinte delle società guerriere che costituiscono parte integrante della tradizione culturale dei popoli nativi. Avvicinandomi allo spiazzo, in modo quasi automatico estraggo la macchina fotografica e comincio a fare qualche scatto, quando Cornelius, la guida che ci aveva accompagnato, si avvicina rapidamente dietro le spalle dicendo: «Hai chiesto prima il permesso?». Con un imbarazzo glaciale mi rendo conto che quello che sembrava un atteggiamento spontaneo e automatico poteva essere interpretato come un’indebita ingerenza, come un gesto ineducato, forse addirittura come un abuso o un sopruso. La situazione spiacevole viene subitaneamente risolta dall’intervento di un membro della comunità, che si avvicina sorridente e mi dice che non ci sono problemi, «è tutto okay», sono arrivato con una persona che loro conoscono e quindi sono accettato come parte della comunità: posso fare le fotografie con tutta tranquillità. Questa situazione può essere considerata come una delle tante, certamente tra le meno gravi, in cui possono incorrere i ricercatori sul terreno con conseguenti errori o gaffe, che possono creare imbarazzo, irritazione, incomprensione o semplicemente ilarità. Tuttavia, la vicenda mi è tornata alla mente molte volte perché illustra anche un’altra cosa: un problema fondamentale che sta alla base di ogni ricerca etnografica e, in fondo, dello stesso sapere antropologico. Gli antropologi «osservano», «studiano», «descrivono» gli altri, coloro presso cui trovano ospitalità, accoglienza, attenzione, disponibilità. Ma che cosa fornisce loro il diritto di effettuare osservazioni, studi e descrizioni di altre persone? La tendenza automatica a prendere la macchina fotografica e a cominciare a scattare non derivava forse dalla convinzione che io ero lì proprio per fare questo, per osservare, documentare, descrivere ciò che stava accadendo? Avevo in qualche modo interiorizzato il ruolo del ricercatore, dando semplicemente per scontato che quanti mi stavano di fronte non fossero altro che parti di una scena in cui io svolgevo il ruolo centrale e determinante. Eppure, non sappiamo tutti che quando si entra in casa d’altri si deve chiedere permesso? Che non possiamo comportarci come faremmo a casa nostra, che dobbiamo mantenere un comportamento adeguato e chiedere se possiamo andare in qualche parte della casa in cui non siamo stati invitati a entrare? E cos’è in fondo la ricerca antropologica se non un entrare in casa d’altri, essere ospitati, seguiti, guidati da qualcuno che si prende cura dello straniero, cerca di agevolarne le esigenze e le finalità, si ingegna per rispondere ai suoi quesiti che a volte sembrano incomprensibili? Accingendomi a scrivere un volume dedicato all’antropologia delle religioni, l’episodio del Michigan mi è tornato in mente con insistenza: la storia delle ricerche e delle teorie antropologiche sulle religioni mostra come gli studiosi si siano spesso posti nei confronti delle tradizioni e pratiche religiose indigene come davanti a «oggetti» da osservare e da indagare, assumendo per ovvio e scontato il proprio ruolo di osservatori e il diritto di «studiare» i propri oggetti. Nonostante le numerose riformulazioni del lavoro etnografico, che in questi ultimi decenni sono state avanzate grazie allo stimolo della critica post- modernista al sapere scientifico, questo atteggiamento disinvolto e autocompiaciuto del ricercatore rimane assai diffuso. Non è certamente un caso se la popolarità degli antropologi tra le culture native, specialmente negli Stati Uniti e in Canada, ma sempre di più anche in Oceania e in altri luoghi, è andata gradualmente scemando quanto più crescevano la consapevolezza dei diritti dei popoli indigeni e la rivendicazione della loro identità culturale. Porsi oggi il problema dello studio delle religioni indigene significa quindi saper rispondere ad alcuni quesiti semplici, ma fondamentali. Perché vogliamo studiarle? Quali finalità intendiamo dare alle nostre ricerche? Perché noi pensiamo di avere il diritto di fare ricerche su di esse? Come possiamo giustificare oggi l’esistenza di una disciplina come l’antropologia delle religioni, in un’epoca in cui le persone che studiamo leggono, spesso con pungente sguardo critico, quello che viene prodotto dagli antropologi (Brettell 1993)? Queste sono le domande che frequentemente un ricercatore si sente rivolgere da parte delle persone che incontra nelle comunità indigene, e alle quali la strumentazione teorica ed epistemologica della disciplina non riesce a dare risposte davvero soddisfacenti, o per lo meno risposte che gli interlocutori dell’antropologo possano ritenere adeguate ed esaurienti. Uno degli obiettivi che questo lavoro si propone, quindi, è quello di cercare di formulare alcune linee di riflessione che possano contribuire alla costruzione di un modello epistemologico in grado di rispondere alle nuove sollecitazioni etiche e metodologiche che le trasformazioni nel rapporto tra ricercatore e comunità indigene impongono. Nei discorsi scambiati in più occasioni con persone appartenenti a culture indigene americane ricorrono frequentemente due concetti, che potrebbero costituire un fertile terreno di incontro tra il sapere antropologico e il sapere tradizionale: quello di «rispetto» (respect) e quello di «condivisione» (sharing). Tra i principali rimproveri che vengono rivolti non tanto a singoli antropologi, quanto all’antropologia come sapere accademico complessivo, figurano infatti quello di non mostrare sufficiente rispetto per le culture native e quello di non aver modo di controllare le forme e le modalità della diffusione delle informazioni che le riguardano. Certo, nel mondo contemporaneo, nelle società complesse, composite e globalizzate, i termini «rispetto» e «condivisione» sono divenuti contenitori vuoti ed espressioni generiche e formali, privi di consistenza e di concretezza. Tuttavia, in molte culture indigene il concetto di «rispetto» è un elemento centrale del pensiero e della pratica religiosa (Bolin 1998). Secondo Thomas Yellowtail, uno specialista delle cerimonie tradizionali tra i Crow del Montana, le diverse prescrizioni rituali che devono essere osservate in occasione delle principali celebrazioni religiose hanno lo scopo di «mostrare grande rispetto per le cose spirituali» (Fitzgerald 1991: 18). «L’atteggiamento dell’uomo nei confronti della natura che lo circonda e degli animali nella natura è di particolare importanza, poiché quando rispettiamo il nostro mondo creato, così mostriamo anche rispetto per il mondo reale che non possiamo vedere» (ivi: 48). «Dal momento che i Padri della Medicina operano attraverso gli animali e la natura, dobbiamo vivere con rispetto nei confronti di tutta la natura, altrimenti perderemo le nostre conoscenze sacre» (ivi: 105). Qui «rispetto» non significa solo una condiscendenza vuota e superficiale, ma un riconoscimento dell’alterità e della sua inesauribilità e inconoscibilità e al tempo stesso l’esigenza di mantenere una relazione con l’alterità, di aprirsi all’altro. La natura, gli animali, le piante vanno rispettati perché sono uno schermo attraverso cui traspare una realtà invisibile, mai completamente conoscibile e controllabile, da cui si possono ottenere istruzioni e potere. Così il rispetto nei confronti degli anziani, di coloro che hanno il compito di condurre una cerimonia, dei parenti e così via, significa mantenere vive le relazioni che legano ciascun individuo ad altre persone, senza le quali la vita individuale sarebbe impensabile e impraticabile. Applicato al campo delle relazioni tra osservatore e osservato, un approssimarsi con rispetto significa un riconoscere «la plausibilità del punto di vista dell’altro» (Cassano 2003: 7), «addentrarsi all’ascolto ed evitare di far andare via lo stupore che ci accompagna quando cerchiamo di porci dal punto di vista di un altro, quando violiamo le leggi di gravità del nostro etnocentrismo» (ivi: VIII). Nel caso dell’antropologia delle religioni, significa abbandonare la più o meno diffusa concezione secondo cui i fenomeni religiosi non siano altro che bizzarrie e stranezze da spiegare o interpretare con distacco e scetticismo. Non vuol dire neanche, ovviamente, che lo studioso deve diventare un credente o un sostenitore delle concezioni religiose che si propone di indagare. Significa soltanto che è necessario avvicinarsi a questi discorsi e a queste pratiche, riconoscendo la loro plausibilità come strumento di interpretazione del mondo e di orientamento per la vita individuale e collettiva. Per giungere a ipotizzare un diverso approccio epistemologico per l’antropologia delle religioni, è risultato di particolare utilità il concetto, anch’esso divenuto sempre più diffuso e generico, di «complessità». In effetti, una delle caratteristiche che hanno accompagnato per lungo tempo lo studio delle religioni indigene è stata la convinzione da parte degli studiosi che esse rappresentassero delle forme semplici, originarie, meno sviluppate e meno raffinate delle religioni storiche e universalistiche. La tendenza a vedere nelle religioni dei popoli indigeni fenomeni semplici è andata di pari passo con l’approccio che concepiva queste religioni come degli «oggetti» curiosi e bizzarri da sottoporre a osservazione e analisi. La consapevolezza, rafforzatasi in questi ultimi anni grazie alla modificazione dei paradigmi scientifici, che queste religioni sono in realtà fenomeni complessi, a volte anche più complessi di certe religioni storiche, contribuisce a modificare anche l’atteggiamento dello studioso, che tende a prendere in maggior considerazione la possibilità che quei fenomeni siano modalità particolari e plausibili di costruire immagini del mondo. Ma il concetto di «complessità» ci può essere utile anche in un modo diverso: non solo per affermare che i sistemi religiosi sono sistemi non facilmente riducibili a pochi fattori esplicativi, ma anche per indagare la possibilità che le stesse religioni siano sistemi di costruzione del mondo che prevedono una qualche considerazione sul problema della complessità. Secondo questa prospettiva, una caratteristica universale e fondamentale di ogni sistema culturale consiste nell’elaborare un’interpretazione della realtà, che si confronta con la complessità del reale e cerca di ordinare i dati dell’esperienza in un sistema del mondo che inevitabilmente tende a ridurre la complessità, attraverso forme di orientamento, di classificazione, di selezione, di identificazione che contribuiscono a costruire un universo di significati in cui l’essere umano possa trovare una propria collocazione. Tuttavia, pur procedendo a una riduzione della complessità, ogni sistema di interpretazione del mondo deve necessariamente fare i conti con una complessità residuale che circonda da ogni parte il mondo costruito dall’uomo e minaccia di penetrare continuamente negli universi di ordine e di stabilità che l’uomo cerca di realizzare. Ogni religione, quindi, si trova necessariamente coinvolta in un continuo processo attraverso il quale si confronta e cerca di difendersi dalla penetrazione della complessità del reale: le strategie possono essere diverse e vanno da un estremo tentativo di salvaguardare l’ordine del mondo, aggrappandosi a forme rigide di riduzione della complessità, all’altro estremo, caratterizzato da una deliberata ricerca ed esplorazione degli aspetti di disordine che consentono una più ampia assimilazione della complessità nella vita umana. L’epistemologia scientifica occidentale ha soltanto da alcuni decenni sviluppato teorie della complessità, mentre i sistemi religiosi si confrontano con la complessità dell’esistenza umana da secoli, e forse da millenni. Questo può essere un terreno favorevole per realizzare un confronto con le elaborazioni religiose dei popoli indigeni che consenta di guardarle con una prospettiva diversa, e che permetta quella circolazione di conoscenze, quella condivisione auspicata da molte culture indigene, in cui il contributo dell’antropologia alla conoscenza della complessità delle religioni indigene si confronta con i contributi che queste stesse religioni hanno fornito alla comprensione delle varie forme in cui si presenta la complessità nell’esistenza umana. Inoltre, il ricorso alla nozione di complessità consente, probabilmente, di superare il dissidio tra il cosiddetto «riduzionismo» delle scienze sociali e l’asserita «autonomia» dei fenomeni religiosi sostenuta da alcuni studiosi delle religioni, in particolare dal noto storico delle religioni Mircea Eliade (Idinopulos - Yonan 1994). La natura complessa dei fenomeni religiosi rende necessario un approccio che escluda il ricorso a riduzioni semplicistiche e schematiche, del tipo: «la religione non è altro che...», le quali, per altro, si sono sempre dimostrate scarsamente fondate dal punto di vista empirico, pur non rinunciando
